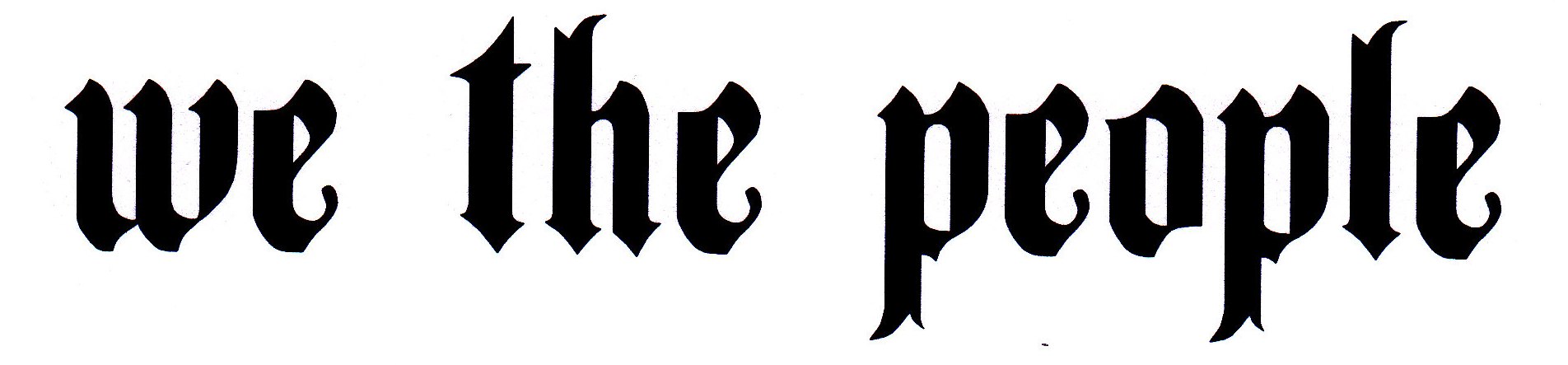L'ESONERO di Antropologia culturale del 21 dicembre si svolgerà in AULA T12A dalle ore 14:00 alle ore 17:00.
CHI PUO' FARE L'ESONERO?
Praticamente TUTTE E TUTTI gli iscritti a qualunque modulo di antropologia culturale (in corso, fuori corso, percorso FIT) negli anni 2017/18 o 2018/19. Modulo A o modulo B.
COME SI SVOLGE LA PROVA?
2017/18, sia modulo A, sia modulo B: 10 domande a risposta aperta da rispondere ENTRO DUE ORE DI TEMPO. PORTATE per cortesia FOGLI PROTOCOLLO e una PENNA SCURA.
2018/19, sia modulo A, sia modulo B: una dozzina di domande a risposta multipla ("crocette") più due domande a risposta aperta da rispondere ENTRO UN'ORA DI TEMPO. Avrete un modulo precompilato con le domande a crocette sul retto e lo spazio per le risposte aperte sul verso del foglio.
PORTATE una PENNA SCURA.
Non dimenticate di portare con voi una CALLIGRAFIA UMANA.
Lasciate a casa lo SPIRITO DI COLLABORAZIONE, visto che devo valutare le vostre prove individualmente, e non ha senso aggiugere ai vostri errori anche quelli del vostro vicino di banco (e viceversa, se siete generosi, evitate di dare consigli; vi assicuro che i vostri vicini di banco sapranno sbagliare benissimo da soli).
Se ci sarà bisogno attiveremo un DOPPIO TURNO per gli studenti del 2018/19 (che dovrebbero essere i più numerosi). Il criterio del doppio turno sarà dichiarato al momento e sarà o alfabetico (prima lettere a-m, o m-z, vediamo; oppure prima matricole pari, o dispari, vedremo; oppure prima cognomi con numero pari di lettere, o dispari, vedremo).
Ho insegnato a Venezia, Lubiana, Roma, Napoli, Firenze, Cosenza e Teramo. Sono stato research assistant alla Queen's University of Belfast e prima ho vissuto per due anni in Grecia, per il mio dottorato. Ora insegno a Tor Vergata e nel campus romano del Trinity College di Hartford (CT). Penso che le scienze sociali servano a darci una mano, gli uni con gli altri, ad affrontare questa cosa complicata, tanto meravigliosa quanto terribile, che chiamano vita.
2011/12: INFORMAZIONI PER CHI AVEVA 12 CFU E TUTTI GLI MP3 DELLE LEZIONI
▼
giovedì 20 dicembre 2018
giovedì 13 dicembre 2018
Natale a Torbella (e al Fienile)
Sabato 15 dicembre dalle 18:00 alle 20:00 ci troviamo al polo ex Fienile (che molti di voi hanno già visto per una lezione ai primi di novembre) per un saluto natalizio. L'antropologia, come avrete capito, rispetta le feste come momento aggregativo importante, pur senza identificarsi nello specifico rituale delle diverse tradizioni.
Le feste sono dei momenti in cui il tempo si raddensa per diversi motivi, le feste natalizie diciamo che sono pensate per intensificare e rafforzare i rapporti sociali tra persone, i legami dunque, la trama e l'ordito di quello che si chiama tessuto sociale.
Delle feste natalizie vogliamo condividere lo spirito di comunità anche attraverso la circolazione di beni in un piccolo sistema di doni. Venite al fienile, dopo i vostri acquisti natalizi, e portate un regalino (anche raccolto da casa, preferiamo non facciate acquisti di cose nuove per questo scambio gioioso) e una piccola cosa da mangiare o bere. Ci scambieremo i regali in un semplice gioco rituale, potremo condividere la com-pagnia (mangiare assieme) che crea relazione sociale e cercheremo di capire assieme il curioso rapporto che tiene assieme le persone tramite le cose. Impareremo che cosa è lo "hau" dei maori, e perché tutti gli oggetti in regalo ne possiedono una piccola ma preziosa scheggia. Chiamatelo brindisi, chiamatelo rito, ma soprattutto chiamatelo un modo per vedere con altri occhiali la realtà che ogni giorno ci circonda. Vogliamo che gli auguri siano un modo di costruire reti sociali più intense, non sperare che il futuro sia migliore, ma cominciare a farlo migliore.
Le feste sono dei momenti in cui il tempo si raddensa per diversi motivi, le feste natalizie diciamo che sono pensate per intensificare e rafforzare i rapporti sociali tra persone, i legami dunque, la trama e l'ordito di quello che si chiama tessuto sociale.
Delle feste natalizie vogliamo condividere lo spirito di comunità anche attraverso la circolazione di beni in un piccolo sistema di doni. Venite al fienile, dopo i vostri acquisti natalizi, e portate un regalino (anche raccolto da casa, preferiamo non facciate acquisti di cose nuove per questo scambio gioioso) e una piccola cosa da mangiare o bere. Ci scambieremo i regali in un semplice gioco rituale, potremo condividere la com-pagnia (mangiare assieme) che crea relazione sociale e cercheremo di capire assieme il curioso rapporto che tiene assieme le persone tramite le cose. Impareremo che cosa è lo "hau" dei maori, e perché tutti gli oggetti in regalo ne possiedono una piccola ma preziosa scheggia. Chiamatelo brindisi, chiamatelo rito, ma soprattutto chiamatelo un modo per vedere con altri occhiali la realtà che ogni giorno ci circonda. Vogliamo che gli auguri siano un modo di costruire reti sociali più intense, non sperare che il futuro sia migliore, ma cominciare a farlo migliore.
lunedì 3 dicembre 2018
Città Identità Mobilità Cultura
L’antropologia è una disciplina che studia i sintomi. Non è
una scienza che possa prevenire (come non lo è la sintomatologia medica) quindi
non dice che cosà accadrà in un qualunque futuro, ma può aiutare moltissimo a
capire che sta succedendo adesso e,
se necessario, prendere qualche contromisura (un’aspirina non è granché, lo
riconosco, ma a volte sapere cosa non
fare in una data situazione è altrettanto importante che sapere cosa fare).
L’attenzione ai sintomi culturali di quel che succede è una
deformazione professionale che credo di aver incorporato profondamente. La mia
psicologa dice che tendo a sovra-interpretare tutto, forse ha ragione, ma non
posso più farne a meno.
Così, quando ho deciso di prendere parte al progetto del
#Dizionario del Macro Asilo e contribuire alla #StanzaDelleParole, avevo ben
chiaro che l’organizzazione di appuntamenti mensili per prendermi cura della
parola #UMANO sarebbe stata una vera battaglia simbolica di definizione della
città di Roma. Il Macro Asilo sta infatti a via Nizza, appena dentro Porta Pia
ma comunque dentro le Mura Aureliane,
che fino al 1870 contenevano tutto quel che ragionevolmente si poteva chiamare
città (e anche un bel po’ di campagna, come sanno tutti). Tor Vergata, la mia
università, invece sta fuori dal
Raccordo, che fu completato nel trentennio 1950-1980, vale a dire il periodo
del sacco urbanistico della città. Nella gestione simbolica dello spazio romano
l’opposizione dentro/fuori è potentissima e gestisce ancora gran parte delle
relazioni spaziali (e sociali, e lavorative) che si possono (o non si possono)
attivare nell’intero ambito urbano.
Normalmente, ho il problema di portare il Dentro (la Città)
verso il Fuori (Tor Vergata) e chiunque organizzi convegni, presentazioni o
qualunque altro tipo di iniziativa a Tor Vergata sa benissimo di cosa parlo:
non ci viene nessuno, se non gli strettissimi interessati, i beneficiari
diretti (studenti cooptati, docenti coinvolti) e qualunque ospite (romano e non
romano, non c’è differenza) mette a punto il suo migliore sguardo spaesato
mentre lo vai a prendere a Anagnina o gli fai vedere le torri di Torbellamonaca
sul lato nord di via Casilina. Stiamo lavorando attivamente su questo tema (la
Scuola di Politica e in generale tutte le attività del LaPE del Fienile sono
orientate anche a spostare Fuori il Dentro) ma quello, dicevo, è un altro
problema rispetto alla relazione con il Macro Asilo, perché in questo caso il
mio compito è l’opposto, vale a dire portare Dentro (nella #StanzaDelleParole
del Macro Asilo, a via Nizza) un pezzo di cittadinanza che si concepisce e si
oggettiva totalmente Fuori (gli studenti e le studentesse di Tor Vergata).
Avendo avuto qualche esperienza pregressa, posso dire con
una certa cognizione di causa che gli studenti (maschi e femmine, scusate, uso
questa semplificazione maschilista che la grammatica ci consente) di Tor
Vergata vivono la mobilità come una sorta di incrocio tra Caos e Destino. Molti
vengono dal quadrante Est della città, molti da fuori Roma, dai Castelli e
oltre. Per loro l’avvicinamento all’Università è sempre di soppiatto, sfidando
autostrade, consolari, vie dei Laghi, treni, pullman, metro troppo lontane e
autobus spesso colmi. Già esserci arrivati è una conquista, un bel pezzo della
giornata portato a casa, visto che poi ci sarà l’ordalia del ritorno,
dell’ingorgo, della voragine, dello sciopero, della pioggia, del blocco, della
Mano di Dio (spesso nella forma di Ordinanza del Sindaco).
So di cosa parlo perché ci sono anch’io, che vengo dal
quadrante Est e me ne vado a Tor Vergata con la macchina per due motivi: primo
perché devo portare i bambini a scuola (che ovviamente, data la competizione
scolastica, vanno a scuola in un quartiere diverso da quello in cui abitiamo) e
non potrei farlo coi mezzi (ci vorrebbero 50 minuti per fare meno di 4 km, dato
che i mezzi pubblici non sono pensati a Roma per collegare i quartieri
trasversalmente, ma solo da e verso il centro); secondo perché con la macchina,
da casa o da scuola dei bimbi, ci metto circa 30 minuti (ora Google maps mi salva
dagli ingorghi, quindi il tempo di percorso si è stabilizzato tra i 25 e i 35
minuti) mentre con i mezzi ci impiego 80 minuti a tratta. Se usassi i mezzi,
dovrei svegliare i bimbi alle 6.45 per uscire di casa alle 7.30, lasciarli a
scuola alle 8.25 e arrivare in studio alle 9.45, e iniziare la mia giornata
lavorativa 4 ore dopo la sveglia. Aggiungete il rientro, i bimbi che escono da
scuola alle 16.20, e mi vedreste risalire sui mezzi alle 15, con una giornata
lavorativa effettiva (concedetemi 30 minuti per il pranzo) di quattro ore e 45
minuti.
Queste cose, fatte le debite proporzioni generazionali, sono
note ai miei studenti, che hanno incorporato (come ogni romano che debba
spostarsi per lavoro o studio, vale a dire tutti o quasi) un istintivo sospetto
per qualunque movimento, sospetto che vira verso il panico quando si tratta di
andare Dentro, in quell’Altrove per molti radicale che è la città entro le
Mura. Lo dico chiaramente, da abitante del semi-fuori: anche per me la
prospettiva di avvicinarmi al centro è ansiogena a prescindere. L’ultima volta
che ho avuto la malaugurata idea di andare con mia moglie e i bambini a vedere
la Lupa Capitolina abbiamo aspettato 50 minuti l’autobus per tornare casa, con
i bambini stanchi e affamati, e io che smadonnavo i miei Maipiù, PiuttostoMorto,
in una litania di abdicazione dalla mia idea di essere un Cittadino di Roma.
Credo che questa reazione, che ognuno di noi vive nella
solitudine imposta dalla stessa frammentazione urbana (si viaggia tutti per
conto proprio, coi propri tempi e con le proprie imprecazioni per i ritardi, le
lungaggini, le totali perdite di tempo) sia parte della disciplina acquisita,
in quel processo di naturalizzazione che chiamiamo cultura. Poco alla volta, ma
in effetti rapidamente, tanto la città è implacabile in questo, impariamo noi
romani che la città è di Qualcun Altro, che ci si sa muovere, che abita lì
vicino, che ha contezza dei posti e dei modi per arrivarci. Noi siamo sempre a
elemosinare un po’ di spazio e un po’ di tempo, sempre intrusi, ospiti
sgraditi, esploratori impacciati e spaventati dell’Altrove Perenne. Qualcuno, i
più fortunati, si inventa accasamenti fittizi, come i ragazzetti che riescono a
gravitare Dentro e hanno battezzato Sanca (la piazza di San Callisto) come luogo
d’elezione (e non a caso l’hanno fatto nella parte popolare più radicalmente
gentrificata della città, ormai assai più vissuta dai city users che non dai pochi residenti superstiti). Ma i più
gravitano attorno ai satelliti del centri commerciali, delle zone residenziali,
dei quartieri senza quartiere, della città anonima.
Non c’è alcun senso di superiorità nel dire questo, nessun
professorume schizzinoso contro la gioventù, nessun “ai miei tempi!” visto che
sono vittima quanto e forse più dei miei studenti di questo modo subalterno di
vivere la città, avendo incorporato prestissimo questa rassegnazione rabbiosa
per uno spazio che non riesco a sentire mio, relegato in una marginalità
spaziale che mi piacerebbe pure (in fin dei conti siamo di fatto in campagna, a
Tor Vergata) se non fosse moralmente connotato dal suo dovere stare alla larga, fuori dalle palle, fuori dalle cose che
succedono (che ovviamente succedono Dentro).
Quindi per me #UMANO era anche un modo per spezzare la
disciplina urbana, invogliare gli studenti (e me stesso!) ad andare Dentro, a
vivere la straordinaria bellezza di una città che, somigliasse un po’ più a sé
stessa, sarebbe la più bella del mondo (e capite che detta da un Veneziano
questa è propria grossa).
La mia educazione cattolica, con il concetto pascaliano di gratia come frutto dell’habitus, unita
al tardo interesse per la nozione marxiana di prassi, mi inducono a credere che
le identità sono prima di tutto forme dell’agire sociale, non del sentire individuale.
Si è per quel che si fa, o si pensa di fare. Se si vive la città come un nemico
ostile che sta altrove non si è cittadini, ma sudditi, e ancora più subalterni
perché non si conosce chi regge il bastone del comando, e si ubbidisce senza
neppure accorgersene, così, perché “tanto che ci vuoi fare”. Portare gli
studenti e le studentesse al Macro Asilo significa violare la regola della
sottomissione urbana, provare a indurre un poco di coscienza di sé come
cittadini che hanno il diritto, non solo il dovere di prendere un titolo di
studio, di apprendere, di elaborare pensiero negli spazi pubblici dove quel
pensiero si produce e articola. Non è giusto, per chi non ce l’ha a portata di
mano, che il Macro sia percepito così
lontano, così altrove, ma questo è quel che mi trovo di fronte e quello che
cerco di gestire, e conosco troppo bene l’orgoglio periferico-borgataro
(ricordo ancora una delle prime scritte a pennarello che lessi sulla metro B,
appena arrivato a Roma: “100# regna”, e non era il Centocelle difficile da
decrittare, ma il motivo per cui regnasse, che mi risultava incomprensibile)
per non riconoscere la natura radicalmente coatta di quell’orgoglio, di quelle
posture romanesche di chi il Dentro proprio non lo conosce, non l’ha mai
conosciuto, lo relega in un antagonismo di classe fittizio (dato che il centro
era popolato dal popolo romano, e quando il popolo ne è stato scacciato si è
semplicemente spopolato, occupato da studi di avvocati e commercialisti, mentre
la borghesia già stava a Città Giardino, e poi a Casal Palocco e poi ancora a
Villaggio Azzurro o Marco Simone, o ai Castelli, appunto).
Per spingere gli studenti a venire più numerosi di quello
che li avrebbe indotti l’inerzia della mobilità (mi è capitato di fare eventi
fuori da Tor Vergata a cui hanno partecipato 3 (tre) studenti dei 250 allora iscritti
al mio corso) ho messo in palio pezzetti di voto finale, sciatterie didattiche
con intento pedagogico, mi viene da dire.
C’è sempre qualcuno che
sbuffa, che hanno l’altro corso in contemporanea, che si alzano alle 4.30, che
uffa insomma sta cosa mica è giusta che uno viene lì e prende un punto e mezzo
e io che invece non posso/non voglio/non so sono costretto dalla mia condizione
di sottomesso alla Regola dell’Alterità Urbana (e c’ho il lavoro, e c’ho i
figli, e c’ho il rientro) a bruciarmi sta occasione. Ci mancherebbe che con
oltre 400 studenti (poi a gennaio arrivano i nuovi del Percorso 24cfu e riparte
la giostra) non ci sia chi sbuffa, o non coglie (o non coglie mentre sbuffa),
ma io tengo duro e per ora la cosa sta funzionando alla grande. Non tanto per
l’affluenza (che è stata molto numerosa nei primi due incontri) ma proprio per
la postura generale che sembra indurre. Nella pagina Facebook del corso se ne
parla, se ne discute in vario modo, ma sento l’effervescenza di qualcosa che
sta succedendo, un piccolo passo verso il Diritto alla Città, mi verrebbe da
dire. Un diritto strappato con la forza, spingendo nella metro o nel bus per
farsi strada, per non fare tardi, perché vale la pena. Vale la pena di
acchiappare per le palle questa città che, se non fai così, se non la tieni a
bada come si deve, ti sfugge e ti sbeffeggia mentre si allontana.
martedì 13 novembre 2018
Sullo sgombero del Baobab experience
Bisogna rimanere lucidi,
e lo dico a tutti, anche a quelli come me che di fronte a tweet di questo tipo
sentono il sangue che ribolle.
Proviamo a restare sulla notizia. Non so quanti fossero gli uomini (in gran parte del Corno d’Africa) che vivevano nell’accampamento
del Baobab
experience. Ma so che erano di fatto invisibili,
auto-segregati nella periferia di Pietralata,
accampati in condizioni assurde ma almeno sottratti allo stato di totale senza
tetto.
Ora Salvini
gioisce (e guadagna consenso,
immagino?) perché quelle centinaia di uomini sono sotto sgombero da parte dalla forza pubblica. Da qualche settimana lo
spiazzo abbandonato (proprietà delle Ferrovie, mi dicono) dove si erano accampati
era stato circondato da una recinzione
di cemento e rete, di fatto recludendo (e rendendo ancora più invisibili) gli
occupanti.
Che promessa ha
fatto, Salvini? Una volta messi per strada, questi uomini si volatizzeranno? Si suicideranno
in massa? Chiederanno di essere rimpatriati?
Oppure andranno semplicemente a occupare nuovi interstizi cittadini, a piccoli gruppi, uno alla volta, pochi alla
volta, più deboli, più miseri, più
emarginati, più incattiviti, più disperati?
Saranno un problema risolto o un problema in
più per la città di Roma, per il quartiere dove vivo? Ci sarà più integrazione
per loro o più malumore per me e
miei vicini, nel vedere questi vagabondi disperati,
affamati, luridi, infreddoliti? Chi starà meglio (a parte i sondaggi di Salvini)?
Il gruppo di volontari che lavorava attorno al Baobab experience cercherà una locazione alternativa? Un poco più in periferia,
forse, tanto per confermare l’idea che Roma è fatta di un centro sacro e intoccabile circondato da un cesso dove si può riversare di tutto?
Se li hai tolti dall’accampamento che cosa hai fatto? Che promessa hai mantenuto? Veramente non
riesco a cogliere il senso né
pratico né simbolico di azioni come queste, che sono esattamente come gli
sgomberi dei campi rom (come ricorda Federico Bonadonna), mosse
propagandistiche che paradossalmente complicano
il problema di cui si pongono come soluzione
radicale.
Di che parole “parla”, Salvini, e quali sono i “fatti”? È una
petizione di principio “zone franche senza Stato e legalità non sono tollerate”? Ha qualche valore
se viene pronunciata dal capo di un partito che per anni si è mosso senza alcuna concezione dello Stato nazionale
e nell’illegalità più grossolana?
Scuola di politica 13 novembre 2018
Stanno sgomberando il baobab
experience, o quel che ne restava dopo il lavoro di recinzione di questi giorni, dietro la Stazione Tiburtina. Sgomberati da via Cupa non so più quante volte,
gli stranieri, i richiedenti asilo e i rifugiati si erano accampati dall’altra
parte della ferrovia, sul versante di Pietralata
e avevano faticosamente cercato di organizzare qualcosa che somigliasse a uno
spazio abitato da esseri umani.
L’immigrazione è un problema perché è stata sempre gestita in Italia come una
condizione emergenziale, da affrontare con misure in parte assistenziali e in
parte vessatorie, senza nessuna volontà di produrre consapevolezza tra i cittadini
italiani e cittadinanza tra gli stranieri immigrati.
Resta un tema centrale della discussione politica, di cui si
sa troppo poco, sul serio, e troppo si sentenzia.
Nella Scuola di
politica del polo ex Fienile ci è sembrato necessario, indispensabile,
parlarne subito, ora, oggi. Dopo aver aperto il mese scorso con Cristian Raimo e Luigi Manconi, oggi verranno al Fienile (largo Mengaroni 29, a Torbellamonaca, a meno di dieci
minuti a piedi dalla fermata Torre Gaia della Metro C) Riccardo
Magi, parlamentare, membro della Commissione Affari Costituzionali della
Camera, e Marco Dotti,
giornalista esperto del Terzo settore, che da tempo si occupa proprio di come
il Terzo settore questione immigrati.
Cerchiamo di mettere assieme i pezzi di questa società impazzita
e malata e frammentata, che non riesce più a pensarsi, che agisce come un pupazzo
a molla, pura reazione a sollecitazioni
intestinali e non riesce più a collegare il cuore con il cervello, la capacità
di ordinare i pensieri per capire il
mondo con i sentimenti che guidino
alla sua modifica per il bene collettivo.
Facciamo politica, venite a fare politica a diventare cittadini, a crescere, a trovare una
ragione non belluina per dire “noi”.
domenica 4 novembre 2018
Mortacci al Fienile, ovvero fare antropologia urbana
L’antropologia culturale è una disciplina lenta, senza
particolari balzi fulminei, sedimenta le cose un poco alla volta. Niente,
credo, che possa equivalere al guizzo notturno del fisico teorico che vede la
soluzione di un lungo rovello in un flash. Lo dico molte volte, ai miei
studenti e alle mie studentesse, che l’antropologia è un lavoro di
consapevolezza infinito, non abbiamo il satori,
l’illuminazione che porta il cammino a compimento. Il nostro modo di ricercare
è più una fragile sequela di petardi che accennano uno scoppio umidiccio, non
abbiamo pistole fumanti da esporre ma solo il setaccio del cercatore di pepite,
che si contenta della pagliuzza, che può mettere in cima alle mille pagliuzze
dorate già raccolte con la pazienza di chi non teme la fatica. Veramente, se
devo pensare a una scienza sostanzialmente modesta nella sua vocazione
teorizzante questa è l’antropologia. Tanto quanto siamo bulimici nella scelta
dell’oggetto (possiamo fare antropologia veramente su tutto, anche sul
non-umano, conferma della nostra vocazione al paradosso) così siamo parchi di
teorie. Ogni tanto ci innamoriamo di qualche concetto (cultura, funzione, struttura,
corpo) ma sono solo coperte di Linus che raccontano il nostro costante sgomento
di fronte alle cose che, semplicemente, scopriamo senza avere mai la certezza
di cosa significhino.
Il LAPE del Fienile, nelle mie intenzioni, è nato per dare
spazio a questa dimensione di sgomento che non trova pace nel metodo, ma solo
nell’impastarsi con quel che dice di voler studiare. L’abbiamo fatto a
Torbellamonaca, il Laboratorio di Pratiche Etnografiche, perché quello è lo
spazio del polo culturale ex Fienile, ma forse non sarebbe potuto nascere da
nessun’altra parte di questa città (che scherzosamente e con la vecchia
passione antropologica per gli ossimori ormai ho battezzato “meravigliosa città
demmerda”) perché Torbellamonaca è insieme un luogo reale, uno spazio abitato
da più di 30mila persone e un luogo dello spirito, quasi dell’immaginario
nazionale, a questo punto. Come le Vele di Scampia, le Torri di Torbella sono
incubi che tutti si possono permettere a buon mercato, un giro nell’immaginario
dell’orrido, tenuto a distanza di sicurezza.
Per questo siamo a Torbella, perché studiare la città dove
la città ammette pubblicamente di aver fallito è un progetto perfettamente antropologico,
la rilevanza del marginale, cercare il tessuto sociale lì dove tutto ti dice
che c’è solo cancrena. E se proprio non lo trovi, non trovi né trama né ordito,
allora ti ci metti tu con i tuoi strumenti antropologici (meravigliosi e
demmerda, ça va sans dire) a intrecciare
qualcosa, a vedere che succede se parli con la signora del bar, se inviti
Mariagrazia della Cgil, se chiedi ai ragazzi di volantinare davanti al Pewex e
davanti ai palazzoni di largo Mengaroni, se ti inventi un nome assurdo
(Mortacci Nostra, che fa pure arricciare il naso a più di un collega a Tor Vergata) per celebrare un Halloween alternativo, che impasti il
ricordo con il bisogno, la storia e i frammenti di vita per vedere se ne esce
qualcosa che somigli almeno un poco alla parola “comunità”.
Avevo pensato da subito che Mortacci Nostra si sarebbe
dovuto fare con un falò, quando quest’estate ho cominciato ad abbozzare il
progetto. Il fuoco ha di suo la forza della sua natura, non devo stare a
spiegarlo. Ho rimandato all’ultimo l’organizzazione della cosa, ma il giorno
prima ho sentito Franko Salkanovic, del campo di Salone, che fa il giardiniere
e se ne intende, per sapere quanta legna sarebbe servita e per chiedergli di
seguire il fuoco per la serata.
Il 31 mattina, dopo che abbiamo portato Pietro Lofaro ad
aiutarci all’ultimo con l’allestimento (che posso dire di lui se non che è
letteralmente un mito, con la sua creatività esplosiva che cerca tutto il tempo
un canale dove riversarsi?) con Simone siamo andati a cercare la legna per il
falò serale. Ci siamo affacciati al piccolo parco incolto di fronte al Fienile,
diciamo che alberi a terra non sono una merce rara di questi tempi a Roma, e
qualcosa siamo riusciti a raccattare. C’era un tronco intero divelto dalla
pioggia che avrebbe forse fatto al caso nostro, ma era troppo grande e troppo
ingombrante, tanto che ci siamo dovuti accontentare di qualche ramo trascinato
a fatica fin dentro il giardino del Fienile e un po’ di fascine. Dopo una
telefonata, siamo andati in un centro di hobbistica in zona e siamo tornati con
sei cassette di faggio già tagliato. Ho pagato le cassette 6 euro l’una.
Quando è arrivato Franko, all’imbrunire, si è reso conto che
la legna probabilmente non sarebbe bastata e mentre stavo salendo in macchina
per tornare all’Università (avevo scordato nel mio studio Le nuvole e i soldi, il libro di Tiziano Scarpa da cui volevo
leggere alcune poesie a tema, una più bella dell’altra, come mi ha confermato
Daniele Casolino del Poetry Slam, che l’ha poi utilizzato per un responsorio
molto bello dentro il teatro del Fienile) l’ho visto in sella al suo motorino.
Gli ho chiesto dove stava andando e mi ha detto di essersi fatto un giro, e che
poco distante, su via di Torbellamonaca (a tre minuti di macchina dal Fienile)
era caduto un albero già morto e tutto secco, che avrebbe fatto perfettamente
al caso nostro. Con la mia macchina siamo andati lì, c’ero passato davanti due
volte quel giorno, ma non l’avevo visto, un tronco di più di sei metri, con
rami lunghi che si spezzavano come grissini facendo leva senza grande fatica, una
volta infilati nella biforcazione di un altro albero che invece era rimasto in
piedi, lì a fianco. Stavamo pulendo un pezzo di strada e ci stavamo procurando
senza spesa un falò meraviglioso, questo pensavo, ma un poco pensavo anche a
una poesia
di Billy Collins, in cui si parla di come l’illuminazione, sempre altrui,
sempre differita, si manifesti a volte nelle persone più umili.
Franko ha quattro figli, una moglie giovane e una forza d’animo
per me commovente. La vita al campo è proprio dura, è inutile infiorettare
aggettivi quando il più secco è anche il più vero. Non so se avete presente gli
zingari del campo di Salone, sgombrati dal Casilino 900 una decina d’anni fa e
ora raggrumati coi nuovi arrivi in una struttura vergognosa e fatiscente.
Forse un’idea però ce l’avete, una vostra idea degli
zingari, dico. Ma a quell’idea vorrei che aggiungeste due altre idee, queste
non sugli zingari, ma degli zingari di Salone. La prima è che
a loro, di venire a Torbellamonaca quando la 21 Luglio ha preso il Fienile, non
è che proprio gli andava. Che ci veniamo a fare, a Torbellamonaca? Dicevano. È un
quartiere pericoloso, pieno di gentaglia di cui non ci si può fidare. Che ne
sappiamo noi che cosa mai ci possono fare, i gagi lì a Torbella? E l’altra idea
invece me l’ha raccontata Nedziba, la moglie di Franko, mentre la
riaccompagnavo a casa (scusate, dovevo dire al campo; un campo non è una casa,
è un posto demmerda senza alcuna meraviglia). L’idea è un incubo, un incubo che
molte mamme rom fanno di frequente, e che proiettano nei vicoli fangosi del
campo, nel buio dove passano le pantegane e i carrelli rubati all’Eurospin. In
quest’incubo uomini bianchi, gagi mascherati, forse albanesi, entrano di sera
per portare via i bambini rom. Probabilmente li vogliono prendere per i
trapianti o dio sa cosa, ma c’è un giro di telefonate che le mamme rom si fanno,
quando il sole finisce, per controllare i bambini, per verificare che questo
incubo non diventi realtà.
Io ci sono cresciuto, con la storia che dovevo stare attento
agli zingari che rubavano i bambini, e mi ha sconvolto ritrovare questo
racconto dell’orrore riaffacciarsi dal campo di Salone, dove gli zingari non
vogliono venire a Torbellamonaca perché “che ne sappiamo noi di quel che voglio
quelli lì?”.
Il reciproco sospetto, ecco il cancro di questo quartiere,
di tutta Roma, di questo Paese, e la necessità di superarlo facendo cose,
raccogliendo legna che marcirebbe sporcando ancora di più questa meravigliosa
città demmerda; organizzando una festa che provava ad essere un rituale per
ricucire un poco le slabbrature del tessuto urbano; un progetto di ricerca che
non è ricerca ma non vuole essere neppure antropologia applicata, ma piuttosto
ricerca-azione. Un progetto, quello del Lape, come seme attivo del Fienile, in
cui la portata del conoscere si misura sul doppio asse del fare e del
condividere. Per me, le parole di Mariagrazia che esce commossa dalla visione
di Coco e che attorno al fuoco e dentro il teatro chiede la parola “perché non
ce la faccio” e deve condividere il suo dolore, sono un piccolo sintomo che la
strada è quella giusta, che il Fienile con il nostro lavoro può diventare il
primo Spazio Pubblico (di tutti) di Torbellamonaca, tutta ancora soffocata nell’antitesi
spaziale (insieme folle e capitalista) del “mio o di nessuno”.
E, vi dico la verità, le rivalità “interne” al Fienile mi procurano
un dolore fisico, perché sono articolate nella stessa logica in fin dei conti
privatistica (“è mio”) che ha massacrato l’edilizia popolare e cancellato gli
spazi pubblici dal vivibile. Dobbiamo recuperare lo spirito di servizio,
aprire, tutti insieme, le porte a questa idea che cerca di prendere il meglio
dell’Oratorio, del Centro sociale, della Casa del Popolo e della Public House.
Noi siamo il seme di un modo diverso di vivere lo spazio in questa città e soprattutto
in questo quartiere: o ci apriamo del tutto, come deve fare un seme, oppure ci
seccheremo come quella caccola di topo che torneremo ad essere se non
accettiamo che non ci sono divieti e non ci sono privilegi su chi può usare il
fienile se intende contribuire alla produzione di cittadinanza. Non ci
interessano gli alambicchi identitari, il “noi” che esiste solo se si
contrappone. Il Fienile sarà lo spazio dove il noi si scioglie nella rete intensificata
dei rapporti umani, oppure non sarà.
mercoledì 17 ottobre 2018
Umano (quanto vi pare)
Inizia giovedì 18 ottobre al Macro Asilo una nuova avventura intellettuale e umana. Una volta al mese, artisti, studiosi, scienziati e performers incontreranno al Macro Asilo quanti vorranno esserci per riflettere, nella "stanza delle parole", sulla parola che mi è stata assegnata e che cercherò di sviluppare in tutte le sue molteplici sfaccettature.
La parola è UMANO, e come non pensare al saluto di Vittorio Arrigoni, "restiamo umani!", ma io ho subito pensato al fatto che umano, nella nostra lingua, incorpora il doppio senso di human e humane, di ciò che ci caratterizza "oggettivamente" come animali (contrapposto a "bovino", per esempio) e che insieme umanizza perché ci rende in grado di provare compassione, sentimenti per l'Altro.
Questa comprensenza di umano animale e umano morale nell'aggettivo UMANO mi è sembrata molto feconda ed è attorno a quella che voglio costruire gli incontri dei mesi a venire.
Abbiamo diverse opzioni di artisti, scienziati, filosofi, genetisti, antropologi che ci racconteranno la loro concezione dell'umano nei mesi del 2019, ma intanto per questi ultimi mesi dell'anno, i primi di apertura del Macro Asilo, il calendario è questo:
ottobre (18, ore 16) Introduco il tema da una prospettiva antropologica
novembre (21, ore 11) Franco Farinelli, uno dei più importanti geografi italiani, ci racconterà in quali condizioni lo spazio diventa spazio umano
dicembre (data da definire) Fabio Dei, antropologo italiano tra i più noti della sua generazione, ci parlerà dei limiti dell'umano, dello sconfinamento nella "disumanità".
Si tratta di un progetto per me molto complesso, perché da antropologo sono esperto (se proprio così si può dire) solo di un lato dell'umanità (quello culturale) ma riconosco che ci sono tanti modi in cui si possa declinare l'aggettivo e riconoscere prospettive diverse dalla mia. Etica e estetica, nelle mie intenzioni, non sono alternative, e vorrei che il progetto UMANO (che a sua volta fa parte di un più ampio progetto #Dizionario) rispondesse agli obietti del nuovo Macro, di riportare l'arte dentro la vita associata: "il museo si fa città" è lo slogan del Macro Asilo e, come antropologo, non potrei trovarlo più allettante per quel che io penso debba essere l'arte, e la vita associata. Si tratta di recuperare anche il vecchio "l'arte come vita, la vita come arte" ma sradicando questa concezione romantica dalle secche dell'individualismo creativo, portando invece a considerare l'arte come "sistema culturale", e gli spazi della vita associata imbevuti di quel sistema e della sue strutture anzi, costituiti da quella strutturazione artistica.
La parola è UMANO, e come non pensare al saluto di Vittorio Arrigoni, "restiamo umani!", ma io ho subito pensato al fatto che umano, nella nostra lingua, incorpora il doppio senso di human e humane, di ciò che ci caratterizza "oggettivamente" come animali (contrapposto a "bovino", per esempio) e che insieme umanizza perché ci rende in grado di provare compassione, sentimenti per l'Altro.
Questa comprensenza di umano animale e umano morale nell'aggettivo UMANO mi è sembrata molto feconda ed è attorno a quella che voglio costruire gli incontri dei mesi a venire.
Abbiamo diverse opzioni di artisti, scienziati, filosofi, genetisti, antropologi che ci racconteranno la loro concezione dell'umano nei mesi del 2019, ma intanto per questi ultimi mesi dell'anno, i primi di apertura del Macro Asilo, il calendario è questo:
ottobre (18, ore 16) Introduco il tema da una prospettiva antropologica
novembre (21, ore 11) Franco Farinelli, uno dei più importanti geografi italiani, ci racconterà in quali condizioni lo spazio diventa spazio umano
dicembre (data da definire) Fabio Dei, antropologo italiano tra i più noti della sua generazione, ci parlerà dei limiti dell'umano, dello sconfinamento nella "disumanità".
Si tratta di un progetto per me molto complesso, perché da antropologo sono esperto (se proprio così si può dire) solo di un lato dell'umanità (quello culturale) ma riconosco che ci sono tanti modi in cui si possa declinare l'aggettivo e riconoscere prospettive diverse dalla mia. Etica e estetica, nelle mie intenzioni, non sono alternative, e vorrei che il progetto UMANO (che a sua volta fa parte di un più ampio progetto #Dizionario) rispondesse agli obietti del nuovo Macro, di riportare l'arte dentro la vita associata: "il museo si fa città" è lo slogan del Macro Asilo e, come antropologo, non potrei trovarlo più allettante per quel che io penso debba essere l'arte, e la vita associata. Si tratta di recuperare anche il vecchio "l'arte come vita, la vita come arte" ma sradicando questa concezione romantica dalle secche dell'individualismo creativo, portando invece a considerare l'arte come "sistema culturale", e gli spazi della vita associata imbevuti di quel sistema e della sue strutture anzi, costituiti da quella strutturazione artistica.
domenica 14 ottobre 2018
Il Punto di svolta (quello di Salvini è fascismo)
Caro Federico,
ti ho letto con attenzione e interesse in questi mesi, le
tue riflessioni sulla situazione politica italiana sono state per me
illuminanti, soprattutto nel farmi comprendere quanto la chiusura del nostro paese verso l’immigrazione e la diversità in
generale sia stata accompagnata da tutti
i governi dell’ultimo trentennio, destra e sinistra. Le tue testimonianze
dirette sulla giunta Veltroni hanno
dimostrato la profondità dell’antiziganismo
come sentimento popolare coccolato
dalle giunte romane, in quegli anni di sinistra dell’amministrazione
capitolina.
Non c’è alcun rigurgito
di fascismo, ci hai insegnato, e io ho ascoltato volentieri, con un senso di amarezza perché la “mia parte” non si
rivelava certo migliore, come mi ero illuso, ma anche con un senso di sollievo, perché l’autoritarismo di
certi capetti sfrontati e rissosi non doveva essere letto come un’anticipazione di ulteriori restrizioni
della libertà di tutti, compresi noi italiani maschi borghesi intellettuali (la
porzione di classe cui apparteniamo
entrambi).
Ti chiedo se dopo la
decisione del Ministro degli Interni
di deportare tutti gli stranieri coinvolti nel “modello Riace” tu mantenga ancora con serenità quella posizione. Io
credo che siamo a una svolta che si
può configurare tecnicamente come svolta
fascista, e sarei felice di sapere che ne pensi, in proposito, tenuto conto
che nel mio immaginario configuri il mondo dei “non ostili ai 5S da sinistra”.
Quelli che, provenendoci, hanno tanto in odio il PD da assumere volentieri
alcuni dei tic linguistici del
MoVimento (e allora il PD?).
L’arresto di Mimmo Lucano non mi ha stupito ed è, nella logica del legalismo ormai imperante in Italia, un
atto dovuto. Abbiamo consegnato una ventina d’anni fa il campo della politica
ai giudici e ai magistrati, che hanno altre unità di misura e le hanno imposte
nello spazio della polis. Amen, è
andata così e quindi è del tutto ovvio che il concetto stesso di disobbedienza civile (che è una nozione
eminentemente politica) non possa trovare spazio nella gestione della cosa
pubblica: se La Legge dice x, e tu
fai una cosa in meno o in più di x, il legalismo dice che commetti un illecito
o un reato, non c’è molto da aggiungere. Se provi ad articolare un discorso sul
valore di x, sulla sua storia, sulle ragioni che hanno fatto sì che si giungesse a x, stai facendo un discorso politico sulla legge, e questo
non è semplicemente più tollerabile
per la maggior parte di chi ci governa e di chi è governato. Quindi, come si
dice, “ci sta” che Lucano venisse arrestato, nel senso che a me la cosa fa
orrore e la considero un’aberrazione folle del sistema politico italiano, ma è
del tutto conseguente al clima generale.
In questa chiave, è paradossalmente
comprensibile anche la “chiusura dei
porti”, e il respingimento dei
richiedenti asilo: se lo stato nazionale è quell’istituzione che demarca il potere che esercita con la
nettezza dei suoi limiti confinari
(fin qui comando io, oltre la linea comanda chi può) è comprensibile (certo non condivisibile
per me, che conosco la storia di formazione di quegli strani oggetti
simbolici detti confini) un atto di sovranismo: chi vuole dimostrare al suo
elettorato di “essere al potere” avrà buone ragioni per marcare
identitariamente i limiti del suo territorio, come un cane che fa territorial pissing con lo stesso
intento di dire: uè ragazzi, fin qui comando io eh!
Ma Salvini imponendo la deportazione di tutti gli stranieri di
Riace, cioè un caso riuscito di integrazione,
ha fatto un’altra mossa, non rivolta a stabilire il dentro e il fuori, ma tutta interna, orientata a dire, a noi
italiani, o con me, o contro di me,
ed è questa la svolta fascista che credo di aver individuato.
Il Ministro degli Interni ha
deciso di delegittimare il “modello Riace” in quanto tale, e l’ha smantellato
interamente deportando tutti i cittadini stranieri (in gran parte riconosciuti
come rifugiati) che vi avevano finora preso parte. Questo non è più legalismo, non è più sovranismo, ma è un’azione politica di
vecchio stampo, un atto puramente politico fascista
che definisce il senso della polis.
Lasciamo stare che “chi sbaglia
paga” lo dica uno che sta pagando in comode
rate, e lasciamo il fatto che “non si possono tollerare irregolarità nell’uso
dei fondi pubblici” lo dica uno che ci ha fatto tollerare 49 milioni di irregolarità che lo riguardavano. Guardiamo la cosa
in sé, e cioè che Salvini sta, con questo gesto, portando a compimento un atto
fondamentale e tipico del “fascismo
eterno” descritto da Umberto Eco,
vale a dire l’individuazione di un nemico che costringe l’intero popolo a
schierarsi, pro o contro. Di fronte a una decisione come quella di
trasferire tutti gli stranieri da Riace, non ci sono vie di mezzo, non ci sono posizioni terziste, non esiste il “sì però” e neppure il “ma anche”. L’intento
è tutto politico, e ricorda la strategia islamo-fascista della al-Qaeda di bin-Laden, il cui piano terrorista era soprattutto
quello di costringere “i moderati” a decidere se stare dalla parte delle
potenziali vittime del terrorismo o
di quelle dei carnefici attivi.
Il piano, poi, è quello storico
dei nazionalismi (di cui il fascismo
è una degenerazione storica quasi inevitabile), la separazione aut-aut tra Patrioti e Traditori, per consentire al capo di turno di avere una presa
immediata e totale sul Noi Patrioti grazie
alla delimitazione chirurgica del Loro
Traditori. Questo è fascismo nel senso più puro: la creazione di un discrimine
che taglia in due la nazione tra chi
è a favore e chi è contro, dissodando tutti i terzismi. Nessuno può restare
veramente indifferente rispetto alla
deportazione di Riace, perché esserlo si configura già come una postura favorevole alla deportazione (chemmefrega dei sti negri), mentre essere
contrario a spostare uomini e donne stranieri integrati nel tessuto locale di
una nazione diventa di fatto un’opposizione
radicale e totale a questo Governo e ai suoi decisori, un atto di tradimento.
Io non avrei mai voluto definirmi anti-salviniano, è proprio
una posizione idiota quella dell’anti-, proprio perché, per ragioni
professionali come puoi ben capire, detesto
essere definito interamente dal mio avversario.
Mi piace pensare che io sono quel che mi piace, sono amante della libertà, della giustizia sociale, dell’eguaglianza
delle opportunità per tutte e tutti, e il mio anti-fascismo è sempre stato una
dimensione latente, poco attiva nel
sentirmi cittadino. Ho sempre riconosciuto l’importanza
storica dell’anti-fascismo, però, vale a dire di quegli uomini e di quelle
donne che hanno veramente combattuto il fascismo quando era al potere, mentre un poco, ti dirò, mi irritava il
rituale post-bellico dell’anti-fascismo quando diventava il cardine dell’identità politica di chi se ne faceva portatore.
Bene, di fronte a Riace io non posso non definirmi anti-Salviniano,
radicalmente, totalmente, senza sconti. Come cittadino veneto, negli anni ottanta
ho resistito con il mio anti-leghismo
a tutti i tentativi di tirarmi dentro il gorgo melmoso dell’identitarismo localista, figuriamoci se
cado ora, proprio io, esperto di nazionalismi e identità etniche, dalla padella
del leghismo alla brace schifosa del “prima gli italiani”. Ho un corso di antropologia culturale con centinaia di
studenti anche quest’anno, mi sa che la
butto in politica.
E se Salvini ci costringe a
prendere parte, sappia che io gli sto
contro, e farò il mio dovere di cittadino
e di intellettuale (tranquilli, i
miei amici che hanno problemi con la parola intellettuale: non mi do un tono, è
solo che dopo aver fatto il pasticcere,
l’operaio in fabbrica, il barista e il portiere d’albergo, da diversi anni mi guadagno da vivere con il
mio cervello e con il mio pensiero, tutto qui, rilassatevi, non
me la tiro). Il mio dovere sarà quello di sollecitare chiunque, e chiedergli se è d’accordo o meno con la deportazione
degli stranieri residenti a Riace, e quali sono le sue ragioni per la sua
scelta.
È iniziata una battaglia, spero non siano i prodromi
di una vera guerra civile, ma se
sarà il caso io so già da che parte stare, e da quale parte proverò ad trascinare
le persone che mi circondano.
martedì 2 ottobre 2018
Quatti quatti
Oggi, 2 ottobre, ho iniziato il corso di antropologia culturale 2018/19 (modulo A fino al 10 novembre, poi parte di fila il modulo B fino a Natale) a Tor Vergata. L'impatto dell'aula T12B (250 posti mi dicono) piena piena è stato piacevole, segno che ancora qualcosa da dire noi antropologi ce l'abbiamo. Ma vediamo chi regge il ritmo di questo corso, insegnato martedì, venerdì e sabato!
Nella colonna di destra di questo blog trovate i primi link, per gli appunti iniziali e soprattutto per il modulo di iscrizione. Quanti intendono fare l'esame in questo anno accademico 2018/19 sono vivamente pregati di compilare il modulo quanto prima (anche se non frequentano). Vi prende un minuto e mi risparmia un sacco di tempo quando dovrò pensare alla valutazione.
Nella colonna di destra di questo blog trovate i primi link, per gli appunti iniziali e soprattutto per il modulo di iscrizione. Quanti intendono fare l'esame in questo anno accademico 2018/19 sono vivamente pregati di compilare il modulo quanto prima (anche se non frequentano). Vi prende un minuto e mi risparmia un sacco di tempo quando dovrò pensare alla valutazione.
venerdì 28 settembre 2018
L’intervista Biografica - Vite migranti al Fienile
Il LAPE (LAbortorio di Pratiche Etnografiche) partecipa nell'ambito di Frascati Scienza alla Notte dei Ricercatori, venerdì 28 settembre e sabato 29.
La Notte dei Ricercatori è un evento ormai consolidato in cui gli scienziati italiani e europei aprono i loro laboratori e osservatori e consentono alla "gente comune" di partecipare alle attività di ricerca.
Uno pensa subito a camici bianchi, provette, bilance, reagenti, ma la ricerca non si fa solo nel mondo naturale, e siamo in tanti a studiare il mondo sociale. Se abbiamo un'idea abbastanza chiara (per quanto probabilmente stereotipata) di come sia fatto un laboratorio di un chimico, com'è fatto il laboratorio di un antropologo?
Per vedere quindi l'antropologia al lavoro partecipiamo al progetto della Notte dei Ricercatori mettendo a disposizione un laboratorio etnografico nel suo farsi. Che significa che il LAPE (guidato in questo caso da Elena Bachiddu, e con il sostegno di Caterina Re) metterà in atto alcune interviste biografiche al polo culturale ex Fienile (sede del Laboratorio) a largo Mengaroni 29, a Torbellamonaca (Roma), venerdì 28 alle ore 20.30 e sabato 29 alle ore 10.30. Due donne verranno intervistate venerdì 28, e due uomini sabato 29. Si raccoglieranno le loro storie, i percorsi migratori, le scelte di vita, i momenti drammatici e quelli felici.
Ogni vita condensa temi sociali, questioni politiche, progetti economici, sistemi morali e raccoglierne la complessità specifica e individuale riconoscendone le determinanti sociali è una sfida intellettuale sempre aperta.
Con questo laboratorio, aperto a tutta la cittadinanza e al quale siete invitati a partecipare numerosi, vogliamo far scoprire la bellezza dell'incontro etnografico, la difficoltà di un'apertura comunicativa, l'impegno che tutti gli interlocutori devono mettere nella costruzione di un dialogo.
Il sapere degli uomini prende strane forme per condensarsi. A volte c'è bisogno di staccarsi dall'oggetto di studio, per vederlo oggettivamente, a distanza, attraverso i filtri dello sguardo scientifico. Altre volte, invece, lo studio prevale sulla scienza, e in quel caso c'è bisogno di contatto, di interazione, di condivisione.
Non si può pretendere di capire come vivono gli uomini se non ci si impegna a conoscerli. E per conoscergli tocca proprio starci assieme, e parlarci.
Venite, venerdì 28 e sabato 29 settembre, a vedere come si fa, al polo ex Fienile di Torbellamonaca.
La Notte dei Ricercatori è un evento ormai consolidato in cui gli scienziati italiani e europei aprono i loro laboratori e osservatori e consentono alla "gente comune" di partecipare alle attività di ricerca.
Uno pensa subito a camici bianchi, provette, bilance, reagenti, ma la ricerca non si fa solo nel mondo naturale, e siamo in tanti a studiare il mondo sociale. Se abbiamo un'idea abbastanza chiara (per quanto probabilmente stereotipata) di come sia fatto un laboratorio di un chimico, com'è fatto il laboratorio di un antropologo?
Per vedere quindi l'antropologia al lavoro partecipiamo al progetto della Notte dei Ricercatori mettendo a disposizione un laboratorio etnografico nel suo farsi. Che significa che il LAPE (guidato in questo caso da Elena Bachiddu, e con il sostegno di Caterina Re) metterà in atto alcune interviste biografiche al polo culturale ex Fienile (sede del Laboratorio) a largo Mengaroni 29, a Torbellamonaca (Roma), venerdì 28 alle ore 20.30 e sabato 29 alle ore 10.30. Due donne verranno intervistate venerdì 28, e due uomini sabato 29. Si raccoglieranno le loro storie, i percorsi migratori, le scelte di vita, i momenti drammatici e quelli felici.
Ogni vita condensa temi sociali, questioni politiche, progetti economici, sistemi morali e raccoglierne la complessità specifica e individuale riconoscendone le determinanti sociali è una sfida intellettuale sempre aperta.
Con questo laboratorio, aperto a tutta la cittadinanza e al quale siete invitati a partecipare numerosi, vogliamo far scoprire la bellezza dell'incontro etnografico, la difficoltà di un'apertura comunicativa, l'impegno che tutti gli interlocutori devono mettere nella costruzione di un dialogo.
Il sapere degli uomini prende strane forme per condensarsi. A volte c'è bisogno di staccarsi dall'oggetto di studio, per vederlo oggettivamente, a distanza, attraverso i filtri dello sguardo scientifico. Altre volte, invece, lo studio prevale sulla scienza, e in quel caso c'è bisogno di contatto, di interazione, di condivisione.
Non si può pretendere di capire come vivono gli uomini se non ci si impegna a conoscerli. E per conoscergli tocca proprio starci assieme, e parlarci.
Venite, venerdì 28 e sabato 29 settembre, a vedere come si fa, al polo ex Fienile di Torbellamonaca.
domenica 23 settembre 2018
Le recchie appizzate
Tra poco iniziano i miei corsi di Antropologia culturale a Tor Vergata (al Trinity College siamo invece già alla terza settimana di lezione) e si riapre il rovello di condensare in trenta ore il senso di una disciplina bulimica e contraddittoria. Gli antropologi possono veramente dire tutto e il suo contrario, quanto a contenuti, ma se devo pensare a una radice metodologica che ci accomuna potrei sintetizzarla nel titolo di questo post, vale a dire nello stare all'erta, nello scrutare sintomi che possono essere letti come indizi di qualcosa più grande, di qualcosa che ancora ci ostiniamo a chiamare cultura.
La foto qui a fianco, ad esempio, condensa (almeno per chi pretende di saperlo leggere) un intero ethos culturale (non scrivo Weltanschauung solo perché ho sempre dei dubbi sull'ortografia delle parole tedesche).
Si tratta di un piccolo gadget da macchina, una finta gruccia che si appende a ventosa sul lunotto posteriore, per avvisare gli altri automobilisti che c'è un "bimbo a bordo" e quindi si pretende la pazienza e la correttezza necessarie a sopportare una guida magari non particolarmente scattante.
1. I genitori sentono l'urgenza di comunicare agli altri di essere genitori: se non mi senti più sgommare, se evito le derapate e i testacoda, sappi che la cosa dipende dal mio stato di maturazione sociale. Mi sono riprodotto, non ho più bisogno di esporre le mie gonadi in atti bellicosi di aggressività stradale, capisciammé: sono un Adulto, ho dei Doveri, il Principio di Realtà si è imposto in forma di seggiolini e pannolini, non ho più tempo da perdere a fare a chi ce l'ha più lungo (ce l'ho più lungo io, ovvio).
2. Questa esternazione pubblica del compimento dei Rito di passaggio alla genitorialità è del tutto recente, mentre non lo è l'atto di essere padre o madre e di scorrazzare la prole in macchina. I miei mi facevano viaggiare sul sedile anteriore, appena dietro la leva del cambio, perché eravamo una marea di figli e non ci si stava tutti sui sedili posteriori. E ai miei non è neppure passato per la mente di rendere pubblico questo loro ruolo sociale di autotrasportatori del proprio DNA. Non si era ancora affacciata l'idea che un genitore sia una chioccia iperprotettiva che deve, lancia in resta, proteggere il suo cucciolo dalle brutture del mondo. All'epoca in cui ero figlio, i figli, oltre che piezz'e core erano pezzi del mondo, li si poteva controllare fino a un certo punto.
3. Ma poi, forse già alla fine degli anni Settanta, sono iniziati a circolare gli adesivi "bimbo a bordo", a invocare la pietà delle altre macchine. La novità, allora (ti annuncio che tengo famiglia) era ancora di tipo generico, mentre ormai da anni l'anagrafe dei lunotti è dettagliata: Attenzione, Carletto, Sabrina, Micol, Manfredi a bordo. Questo salto del livello di personalizzazione è significativo dello stesso percorso di privatizzazione della genitorialità: ma cosa pensi, che io sono UN genitore? Che magari ho UN figlio o UNA figlia a caso, come fossero tutti uguali e intercambiabili? No, tu mi porti rispetto perché io ho Davide (Carlotta, Filippo, Giovanna) a bordo, vale a dire una persona talmente unica che la posso nominare pubblicamente senza timore di fraintendimenti.
4. E in effetti, la nominazione dei figli ha seguito questo percorso ultra-specifico, per cui una qualità essenziale del nome è la sua potenziale unicità. Chiamalo Attila, o Artù, Teodolinda o Selvaggia, basta che siano gli unici della loro specie, almeno in quartiere, almeno a scuola. La statistica ci spiega che è un gioco a perdere, perché se tutti evitiamo i nomi delle nonne finiremo per chiamare le figlie Rebecca (come ho fatto io il nel 2001) senza renderci conto che i vicini di casa facevano esattamente lo stesso gioco, vanificando l'obiettivo iniziale e dando la stura alla proliferazione degli Ethan e delle Elettre (al punto che conviene oggi chiamare la neonata Maria e il neonato Giuseppe, se si vuole essere certi che il loro nome sia unico nel circondario).
5. Nei nomi dei figli troviamo quindi oggi non più la sedimentazione di una linea genealogica (mio cugino Salvatore, che mi ha passato la foto, è figlio di Paolo, figlio di Salvatore, figlio di Paolo, e penso che si possano ipotizzare con facilità i nomi degli antenati precedenti) ma piuttosto la condensazione di immaginari che perseguono gli stessi tortuosi percorsi collettivi di privatizzazione individuale: peschiamo dall'immaginario collettivo e, ognuno come cavolo ci pare, tiriamo giù dall'archivio la connessione che più ci attizza, il simbolo che più ci si confà, la narrazione più vicina ai nostri stati d'animo (con il problema già indicato, che ci sentiamo unici nel fare questo, ma il materiale da cui peschiamo è per forza disponibile anche ad altri, con il rischio che la scelta finale sia la stessa).
6. Kevin Pio è una mossa geniale perché incrociando due campi semantici in gran parte distinti (Hollywood e il Cattolicesimo tradizionale italiano) riduce moltissimo la possibilità di omonimi. Ma a chi altri, nel mondo, veramente, sarà mai venuto in mente di chiamare il figlio con il nome di un belloccio americano che ballava coi lupi e di un santo italiano con le mani bucate dalle stigmate? Un nome del genere ci dice intanto quali sono due sorgenti essenziali di questo immaginario sedimentato nei figli: la macchina dell'immaginario mediatico, e la più antica istituzione europea nella sua versione ultrapop. Kevin Costner balla coi lupi, si sa: ci dice che possiamo ancora avere un rapporto armonioso con la Natura, che in quella Natura troveremo almeno Alzata Con Pugno, una di noi ma anche parte di quella Natura. Padre Pio invece ci dice che oltre le gonne (del prete) c'è di più, che il rito stantio del Cattolicesimo ha ancora una forza sciamanica, che il mondo, nonostante Weber, è ancora passibile di incantamento, che non siamo condannati al cieco cinismo del secolarismo laicista. Che a noi personalmente può anche fregare poco (basta che c'è la Maggica e il mondo è già incantato a sufficienza) ma per il nostro virgulto ci aspettiamo un Mondo Sensato. E poi, non sia mai che si butta via la Protezione di un tipo tanto potente da fare veramente i miracoli.
7. E così, nel lunotto di un'auto parcheggiata l'antropologia ci trova condensate un sacco di "cose culturali": cosa vuol dire essere un vero adulto e un buon genitore; cosa intendiamo oggi per individuo; quale idea abbiamo del nostro rapporto con la Natura; addirittura cosa Crediamo nel senso più impegnativo del verbo. Certo, non sono concetti culturali esposti con la compiutezza di un saggio o di una riflessione pubblica consapevole, sono solo fugaci accenni, poco più che scarabocchi che potrebbero non significare nulla ma dentro i quali noi antropologi cerchiamo di trovare un senso. E a chi dice che queste cose non contano nulla, che le determinanti del vivere associato sono ben altre, io posso solo rispondere usando i miei strumenti: pensate che effetto vi farebbe se il piccolo Kevin Pio si fosse chiamato Mao Marchionne oppure Francesco Paperone. Tutti vi vedreste un sovraccarico di senso e comincereste a indagarlo. Questo fa l'antropologia, sempre: crede che quel sovraccarico culturale ci sia in ogni azione e sedimento culturale, e prova a inseguirne le tracce anche se si tratta solo di un piccolo gadget nel lunotto posteriore di un'auto parcheggiata.
La foto qui a fianco, ad esempio, condensa (almeno per chi pretende di saperlo leggere) un intero ethos culturale (non scrivo Weltanschauung solo perché ho sempre dei dubbi sull'ortografia delle parole tedesche).
Si tratta di un piccolo gadget da macchina, una finta gruccia che si appende a ventosa sul lunotto posteriore, per avvisare gli altri automobilisti che c'è un "bimbo a bordo" e quindi si pretende la pazienza e la correttezza necessarie a sopportare una guida magari non particolarmente scattante.
1. I genitori sentono l'urgenza di comunicare agli altri di essere genitori: se non mi senti più sgommare, se evito le derapate e i testacoda, sappi che la cosa dipende dal mio stato di maturazione sociale. Mi sono riprodotto, non ho più bisogno di esporre le mie gonadi in atti bellicosi di aggressività stradale, capisciammé: sono un Adulto, ho dei Doveri, il Principio di Realtà si è imposto in forma di seggiolini e pannolini, non ho più tempo da perdere a fare a chi ce l'ha più lungo (ce l'ho più lungo io, ovvio).
2. Questa esternazione pubblica del compimento dei Rito di passaggio alla genitorialità è del tutto recente, mentre non lo è l'atto di essere padre o madre e di scorrazzare la prole in macchina. I miei mi facevano viaggiare sul sedile anteriore, appena dietro la leva del cambio, perché eravamo una marea di figli e non ci si stava tutti sui sedili posteriori. E ai miei non è neppure passato per la mente di rendere pubblico questo loro ruolo sociale di autotrasportatori del proprio DNA. Non si era ancora affacciata l'idea che un genitore sia una chioccia iperprotettiva che deve, lancia in resta, proteggere il suo cucciolo dalle brutture del mondo. All'epoca in cui ero figlio, i figli, oltre che piezz'e core erano pezzi del mondo, li si poteva controllare fino a un certo punto.
3. Ma poi, forse già alla fine degli anni Settanta, sono iniziati a circolare gli adesivi "bimbo a bordo", a invocare la pietà delle altre macchine. La novità, allora (ti annuncio che tengo famiglia) era ancora di tipo generico, mentre ormai da anni l'anagrafe dei lunotti è dettagliata: Attenzione, Carletto, Sabrina, Micol, Manfredi a bordo. Questo salto del livello di personalizzazione è significativo dello stesso percorso di privatizzazione della genitorialità: ma cosa pensi, che io sono UN genitore? Che magari ho UN figlio o UNA figlia a caso, come fossero tutti uguali e intercambiabili? No, tu mi porti rispetto perché io ho Davide (Carlotta, Filippo, Giovanna) a bordo, vale a dire una persona talmente unica che la posso nominare pubblicamente senza timore di fraintendimenti.
4. E in effetti, la nominazione dei figli ha seguito questo percorso ultra-specifico, per cui una qualità essenziale del nome è la sua potenziale unicità. Chiamalo Attila, o Artù, Teodolinda o Selvaggia, basta che siano gli unici della loro specie, almeno in quartiere, almeno a scuola. La statistica ci spiega che è un gioco a perdere, perché se tutti evitiamo i nomi delle nonne finiremo per chiamare le figlie Rebecca (come ho fatto io il nel 2001) senza renderci conto che i vicini di casa facevano esattamente lo stesso gioco, vanificando l'obiettivo iniziale e dando la stura alla proliferazione degli Ethan e delle Elettre (al punto che conviene oggi chiamare la neonata Maria e il neonato Giuseppe, se si vuole essere certi che il loro nome sia unico nel circondario).
5. Nei nomi dei figli troviamo quindi oggi non più la sedimentazione di una linea genealogica (mio cugino Salvatore, che mi ha passato la foto, è figlio di Paolo, figlio di Salvatore, figlio di Paolo, e penso che si possano ipotizzare con facilità i nomi degli antenati precedenti) ma piuttosto la condensazione di immaginari che perseguono gli stessi tortuosi percorsi collettivi di privatizzazione individuale: peschiamo dall'immaginario collettivo e, ognuno come cavolo ci pare, tiriamo giù dall'archivio la connessione che più ci attizza, il simbolo che più ci si confà, la narrazione più vicina ai nostri stati d'animo (con il problema già indicato, che ci sentiamo unici nel fare questo, ma il materiale da cui peschiamo è per forza disponibile anche ad altri, con il rischio che la scelta finale sia la stessa).
6. Kevin Pio è una mossa geniale perché incrociando due campi semantici in gran parte distinti (Hollywood e il Cattolicesimo tradizionale italiano) riduce moltissimo la possibilità di omonimi. Ma a chi altri, nel mondo, veramente, sarà mai venuto in mente di chiamare il figlio con il nome di un belloccio americano che ballava coi lupi e di un santo italiano con le mani bucate dalle stigmate? Un nome del genere ci dice intanto quali sono due sorgenti essenziali di questo immaginario sedimentato nei figli: la macchina dell'immaginario mediatico, e la più antica istituzione europea nella sua versione ultrapop. Kevin Costner balla coi lupi, si sa: ci dice che possiamo ancora avere un rapporto armonioso con la Natura, che in quella Natura troveremo almeno Alzata Con Pugno, una di noi ma anche parte di quella Natura. Padre Pio invece ci dice che oltre le gonne (del prete) c'è di più, che il rito stantio del Cattolicesimo ha ancora una forza sciamanica, che il mondo, nonostante Weber, è ancora passibile di incantamento, che non siamo condannati al cieco cinismo del secolarismo laicista. Che a noi personalmente può anche fregare poco (basta che c'è la Maggica e il mondo è già incantato a sufficienza) ma per il nostro virgulto ci aspettiamo un Mondo Sensato. E poi, non sia mai che si butta via la Protezione di un tipo tanto potente da fare veramente i miracoli.
7. E così, nel lunotto di un'auto parcheggiata l'antropologia ci trova condensate un sacco di "cose culturali": cosa vuol dire essere un vero adulto e un buon genitore; cosa intendiamo oggi per individuo; quale idea abbiamo del nostro rapporto con la Natura; addirittura cosa Crediamo nel senso più impegnativo del verbo. Certo, non sono concetti culturali esposti con la compiutezza di un saggio o di una riflessione pubblica consapevole, sono solo fugaci accenni, poco più che scarabocchi che potrebbero non significare nulla ma dentro i quali noi antropologi cerchiamo di trovare un senso. E a chi dice che queste cose non contano nulla, che le determinanti del vivere associato sono ben altre, io posso solo rispondere usando i miei strumenti: pensate che effetto vi farebbe se il piccolo Kevin Pio si fosse chiamato Mao Marchionne oppure Francesco Paperone. Tutti vi vedreste un sovraccarico di senso e comincereste a indagarlo. Questo fa l'antropologia, sempre: crede che quel sovraccarico culturale ci sia in ogni azione e sedimento culturale, e prova a inseguirne le tracce anche se si tratta solo di un piccolo gadget nel lunotto posteriore di un'auto parcheggiata.
mercoledì 13 giugno 2018
L'Università, l'antimafia delle periferie
Giovedì 14 giugno dalle ore 10.30 ci si trova al Centro Anziani di via Via Giuseppe Gregoraci, 140, a Roma, per parlare (anche) del ruolo dell'Università del rafforzamento del tessuto sociale.
Questo è il testo del pezzo di Repubblica Roma che ha organizzato l'evento:
"L'Università, l'antimafia delle periferie". E' il tema dell'incontro in programma il 14 giugno alle 10.30 presso il Centro anziani di via Gregoraci 140 della Romanina. E’ il nuovo appuntamento organizzato da QUELLI del Roxy Bar nell’ambito della serie di iniziative “Illuminiamo le periferie”. Il caffè della legalità va avanti.
Si inizia come al solito con la lettura dei giornali con i cittadini e con gli studenti delle scuole del quartiere. Laboratorio di scrittura curato dai giornalisti di varie testate. Partecipano: Pietro Vereni docente dell'Ateneo di Tor Vergata; Giuseppe De Marzo responsabile nazionale di Libera per le politiche sociali; Francesca Re David, segretaria generale Fiom; Valerio Carocci del Cinema America; Paolo di Vetta, Movimenti per il diritto all'abitare; Fabrizio Di Meo, presidente del Cdq Romanina, Angelo Sciotto e Pergiorgio Fadanelli di Link Altro Ateneo Tor Vergata.
Verranno premiati i ragazzi del municipio VII e gli studenti dell'Istituto comprensivo Raffaello, diretto dalla dirigente scolastico Chiara Pinti, che accompagnati dagli instancabili docenti hanno partecipato e dato vita ai laboratori di scrittura. Collegamenti con Articolo 1, con il Giornale radio Sociale e Ivano Maiorella. All’incontro è presente anche Orfeo Pagnani, ExOrma editore.
Il nuovo appuntamento nell'ambito di "Illuminiamo le periferie" è promosso da #QuellidelRoxyBar, un gruppo di associazioni del sociale e di giornalisti: da Libera, Rete dei Numeri Pari, Rete NoBavaglio, Articolo 21, Ordine dei Giornalisti, Ateneo Tor Vergata, Comitato di Quartiere Romanina, Cinecittà Bene Comune, Cgil Roma Sud, daSud, Link e Terzo Settore. “E poi andremo a prendere il caffè al Roxy Bar come al solito – assicurano Quelli del Roxy Bar - con le stesse parole d’ordine: #RipartiamodallaRomanina e #NonPerNoiMaPerTutti non solo slogan ma un progetto di lavoro che sta prendendo forma e che proseguirà nei prossimi mesi”.
Questo è il testo del pezzo di Repubblica Roma che ha organizzato l'evento:
"L'Università, l'antimafia delle periferie". E' il tema dell'incontro in programma il 14 giugno alle 10.30 presso il Centro anziani di via Gregoraci 140 della Romanina. E’ il nuovo appuntamento organizzato da QUELLI del Roxy Bar nell’ambito della serie di iniziative “Illuminiamo le periferie”. Il caffè della legalità va avanti.
Si inizia come al solito con la lettura dei giornali con i cittadini e con gli studenti delle scuole del quartiere. Laboratorio di scrittura curato dai giornalisti di varie testate. Partecipano: Pietro Vereni docente dell'Ateneo di Tor Vergata; Giuseppe De Marzo responsabile nazionale di Libera per le politiche sociali; Francesca Re David, segretaria generale Fiom; Valerio Carocci del Cinema America; Paolo di Vetta, Movimenti per il diritto all'abitare; Fabrizio Di Meo, presidente del Cdq Romanina, Angelo Sciotto e Pergiorgio Fadanelli di Link Altro Ateneo Tor Vergata.
Verranno premiati i ragazzi del municipio VII e gli studenti dell'Istituto comprensivo Raffaello, diretto dalla dirigente scolastico Chiara Pinti, che accompagnati dagli instancabili docenti hanno partecipato e dato vita ai laboratori di scrittura. Collegamenti con Articolo 1, con il Giornale radio Sociale e Ivano Maiorella. All’incontro è presente anche Orfeo Pagnani, ExOrma editore.
Il nuovo appuntamento nell'ambito di "Illuminiamo le periferie" è promosso da #QuellidelRoxyBar, un gruppo di associazioni del sociale e di giornalisti: da Libera, Rete dei Numeri Pari, Rete NoBavaglio, Articolo 21, Ordine dei Giornalisti, Ateneo Tor Vergata, Comitato di Quartiere Romanina, Cinecittà Bene Comune, Cgil Roma Sud, daSud, Link e Terzo Settore. “E poi andremo a prendere il caffè al Roxy Bar come al solito – assicurano Quelli del Roxy Bar - con le stesse parole d’ordine: #RipartiamodallaRomanina e #NonPerNoiMaPerTutti non solo slogan ma un progetto di lavoro che sta prendendo forma e che proseguirà nei prossimi mesi”.
martedì 29 maggio 2018
Lo sciacallo, il bufalo e il formichiere
La strada che
univa la savana al villaggio era
battuta e tenuta pulita dal formichiere.
Lo sciacallo (famoso per la sua ferocia
più che astuzia) e il bufalo (noto
per la sua ottusità piena di livore) decisero che era ora di andare al
villaggio e di prenderne possesso, e si accordarono per fare la strada assieme. Qualcuno diceva che non c’era nulla in comune tra i due, se non la
meta finale, ma altri sostenevano che in realtà sciacallo e bufalo avessero un antenato comune. Altri, addirittura,
prevedevano un’unione tra i due che
avrebbe portato alla nascita di una nuova
specie.
Durante la notte, lo sciacallo avanzò sul percorso e scavò una trappola, esattamente al
centro del sentiero, proprio lì dove
il formichiere sarebbe passato nel suo lavoro di battitura e di pulizia. Prima
dell’alba, lo sciacallo tornò indietro portando un po’ di colazione al bufalo,
che ancora dormiva della grossa.
Mettendosi all’opera di buon mattino, il formichiere teneva
pulito il sentiero da pietre, arbusti e insetti, di modo che i viandanti
diretti al villaggio potessero farlo nella maniera più agevole. Preso dalla cura con cui era solito fare il suo
lavoro, precipitò rovinosamente nella
trappola, scoprendo quindi la buca
che ora rendeva di fatto il sentiero impraticabile.
Avvicinandosi al villaggio, lo sciacallo e il bufalo si videro
la strada interrotta dalla buca in
cui, ammaccato, giaceva il formichiere.
– Ma come facciamo, ora? Iniziarono a lamentarsi.
– Avevamo progettato con grande cura questo viaggio, il
villaggio ormai era a portata di mano, è folle che tu, formichiere, ti intrometta
impedendo la legittima realizzazione
del nostro percorso.
Il formichiere, ammaccato, rimuginava sul suo zelo: se solo
fosse stato meno scrupoloso, se
avesse cercato con meno attenzione del solito di tenere la strada pulita, forse
avrebbe evitato la buca e non avrebbe
così ostacolato involontariamente lo sciacallo e il bufalo. Paradossi del
potere, pensò: certe volte ti danno un incarico
e lo persegui con tanto zelo da ottenere l’effetto opposto.
– Dai, togliti di mezzo o ti togliamo noi! Strepitò il
bufalo, imbufalito ancor più di
quanto non lo spingesse la sua naturale inclinazione.
La favola africana, come molte, si interrompe a questo punto, con un ultimo, incomprensibile
dettaglio (è tipico dei racconti esotici essere in gran parte incomprensibili per noi, esseri
superiori guidati dalla razionalità dell’azione causale e consequenziale). Gli abitanti del villaggio, saputa la storia,
si divisero in due fazioni: quelli
che biasimarono il formichiere per
essersi frapposto al cammino dello sciacallo e del bufalo (impedendo così al villaggio il cambiamento
auspicato), e quelli che lo lodarono
con pubblici peana per lo stesso identico motivo (salvando il villaggio dalla devastazione).
Tutti lì a discettare se il formichiere fosse o meno caduto necessariamente nella buca, se l’avesse
fatto apposta, se fosse stato calcolato, se avesse pensato alle conseguenze di quel gesto, e che cosa
sarebbe successo allora.
Ben pochi, però, si chiesero come mai ci fosse quella buca, chi
l’avesse messa proprio lì, al centro
del sentiero dove il formichiere non
poteva non passare, e quale ne fosse la finalità. L’ultimo a
farsi la domanda fu ovviamente il bufalo.
Ma dal bufalo nessuno si era mai aspettato un po’ di pensiero. Ci si accontentava
del suo sbuffare, come era naturale
per lui.
lunedì 28 maggio 2018
Sulla volontà popolare
Provo a sintetizzare quel
che va detto, da fuori, rispetto alla questione Mattarella-Savona.
Era già successo che il Presidente della Repubblica in carica si
rifiutasse di nominare un Ministro proposto dal Presidente del Consiglio
incaricato. Quali che fossero le sue ragioni (vedi oltre), Mattarella ha
esercitato una sua prerogativa legittimata
dalla Costituzione e consolidata dalla prassi.
Non era mai successo, invece, che un Presidente del Consiglio
incaricato si rifiutasse di proporre alternative, una volta esposto al rifiuto
del Presidente della Repubblica. Questa è l’azione inusitata successa ieri, che cioè Conte non ha accettato le
indicazioni di Mattarella di mettere un politico eletto come Ministro dell’economia.
Come mai Conte è stato inflessibile al punto di veder fallire
il suo mandato? Delle due, l’una.
1. Savona era considerato
indispensabile in quella posizione. Perché?
L’unica lettura ragionevole è che il governo voleva veramente informare l’UE
che considerava plausibile e
perseguibile un’uscita dall’euro. Questo punto non era stato discusso in questi
termini durante la campagna elettorale, né da Lega, né da M5S, che anzi si
erano premuniti di garantire gli investitori e le istituzioni che la loro
posizione, per quanto critica, sarebbe proseguita nell’alveo dell’unione
monetaria. Visto che insomma il punto “uscire dall’euro” non era nei programmi, bene ha fatto Mattarella a stoppare una sua introduzione
surrettizia con Savona.
2. L’impuntatura leghista
su Savona è stata un bluff win/win
per la Lega: se Mattarella avesse ceduto si sarebbe creata una ferita
insanabile nel corpo dello Stato, con l’esecutivo che ribalta i rapporti di
potere e di garanzia tra Presidente delle Repubblica e Presidente del
Consiglio. A quel punto, il Governo avrebbe avuto carta bianca su tutto,
segnando un cambio costituzionale de facto (altro che gomblotto, sarebbe
stato un piccolo colpo di stato tutto a vantaggio del Governo in carica). La
resistenza di Mattarella garantiva invece alla Lega un ottimo argomento per rompere con il moribondo Centrodestra di Berlusconi, raccoglierne i miseri resti e puntare alle
prossime elezioni direttamente in alleanza/competizione con il M5S (con i 5S in posizione di
vassallaggio, questa volta).
Qualcuno, soprattutto a sinistra (in quella sinistra a
sinistra del PD renziano in cui, se esistesse, mi riconoscerei) ha sollevato
questioni sulla sovranità popolare,
che sarebbe stata schiacciata da Mattarella a favore della Capitale e della
Finanza che, per mano teutonica, avrebbe sancito ancora una volta l’inutilità del voto nelle democrazie mediterranee
(accomunandoci coi greci e i catalani).
Bene, a questi amici
ricordo che, chiunque abbia vinto le elezioni del 4 marzo, non ha vinto un referendum per uscire dall’euro o per cambiare
la Costituzione con un colpo di mano. A me non risulta che ci sia stato chiesto
se volevamo o meno uscire di soppiatto dalla moneta unica, non ricordo il
professor Savona indicato in quella posizione da Salvini o Di Maio (mentre ricordo
le posizioni del professore su come
uscire dall’euro nei weekend).
Se restiamo ancorati a
questo feticcio del popolo che avrebbe espresso la sua volontà, guardiamoci negli occhi e parliamo schietto: non ho
visto nessun popolo che abbia deciso di avere un ministro dell’economia pronto alla Brexit italiana. Nessun
proprietario di casa, pagatore di mutuo, riscossore di pensione o possessore di
qualche risparmio, nessuno di coloro che l’hanno sfangata in questi dieci anni
tenendo duro ha veramente voglia del “tanto
peggio tanto meglio”. E non a caso i marginali (carcerati, stranieri di
ogni sorta, occupanti abusivi, irregolari di ogni sorta) sono stati l’obiettivo
primo degli attacchi del Contratto di Governo. Chi comunque ha galleggiato, per
quanto a fatica, non è così pazzo da volere lo sfascio totale in nome del mal
di pancia al potere.
I Poteri Forti, semmai, sono quelli che vorrebbero proprio questo: l’uscita
unilaterale dell’Italia dai trattati, vale a dire l’Italexit. Ma non parlatemi
di volontà popolare, per cortesia, perché Savona Ministro dell’economia NON è la volontà popolare, dai.
Alla prossima campagna
elettorale farò una sola domanda a
tutti quelli che mi chiederanno il voto: avete nostalgia della lira? Volete uscire
dall’euro? Volete porre dei dictat all’UE che corrispondono a un’uscita
unilaterale dall’Unione?
Se siete i rappresentati del Popolo, se il Popolo siete
voi, state molto attenti a rispondere chiaramente alle domande che il Popolo vi
farà.
venerdì 18 maggio 2018
Un semplice conteggio
Punto 12. Immigrazione: rimpatri e stop al business
“Occorre prevedere, contestualmente, l’individuazione di sedi di permanenza temporanea finalizzate al rimpatrio, con almeno uno per ogni regione, previo accordo con la Regione medesima, e con una capienza tale da garantire il trattenimento di tutti gli immigrati il cui ingresso o soggiorno sia irregolare, presenti e rintracciati sul territorio nazionale […]ad oggi sarebbero circa 500 mila i migranti irregolari presenti sul nostro territorio […]il trattenimento deve essere disposto per tutto il periodo necessario ad assicurare che l’allontanamento sia eseguito, fino ad un massimo complessivo di diciotto mesi”
Quindi vanno individuati almeno 20 (uno per Regione) sedi di permanenza temporanea in grado,
complessivamente, di trattenere 500mila
persone fino a 18 mesi.
In pratica, devono essere individuate 20 sedi in grado di gestire ognuna 25mila (500mila irregolari
diviso 20 regioni) persone per 18
mesi l’una.
In Italia, dati
del Ministero della Giustizia, abbiamo circa 58mila persone detenute
nelle carceri italiane.
Rebibbia
Nuovo Complesso è il più grande
carcere d’Italia e attualmente ospita oltre 1400 detenuti (circa 200 in
più dei posti regolamentari)
Quindi il contratto di governo prevede che vengano
individuate in Italia almeno 20 sedi
grandi ciascuna come 20 volte Rebibbia
(25000 diviso 1200 uguale più di 20).
Oppure, se ci si volesse limitare alla capacità attuale di Rebibbia (1200 posti) sarà necessario individuare
(500mila diviso 1200) almeno 416 sedi di
permanenza temporanea grandi come Rebibbia
su tutto il territorio nazionale, vale a dire una media di 20 Rebibbie per ogni regione italiana.
Calcolando che a Rebibbia sono previsti 992 effettivi della polizia
penitenziaria, e 92 amministrativi per mandare avanti la
baracca (non conto gli educatori del carcere, che agli immigrati irregolari ovviamente non
serviranno), e stimando che, vista l’ipotizzabile ridotta pericolosità degli
immigrati regolari rispetto alle persone attualmente detenute nelle carceri,
con un numero dimezzato (500 poliziotti e 50 amministrativi per ogni sede di permanenza temporanea) di personale
si possa gestire il tutto, ci sarà bisogno di
500 membri di
polizia e 50 amministrativi per ognuna delle 416 sedi di permanenza temporanea, per un totale di
208mila effettivi
di polizia (500 per 416)
20.800
amministrativi (50 per 416)
Vale a dire garantiti 228.800
posti pubblici assicurati.
Con 416 sedi (molte da costruire) e 230mila nuovi posti di lavoro nell'Amministrazione Pubblica il paese riparte.
Destinazione inferno.
lunedì 14 maggio 2018
VOTI FINALI per chi ha superato lo scritto del 21 aprile 2018
QUI trovate il file, che è nella solita cartella studenti.
Come specifico nel file, vale il principio del silenzio-assenso e tra due giorni chiudo il verbale elettronico.
Come specifico nel file, vale il principio del silenzio-assenso e tra due giorni chiudo il verbale elettronico.
mercoledì 9 maggio 2018
LE religionI di Roma
 Con molto piacere partecipo mercoledì 9 maggio alla presentazione del libro Roma città plurale, curato da Alessandro Saggioro e Carmelo Russo.
Con molto piacere partecipo mercoledì 9 maggio alla presentazione del libro Roma città plurale, curato da Alessandro Saggioro e Carmelo Russo.Con Valeria Fabretti abbiamo scritto un capitolo in cui cerchiamo di riflettere sulla schizofrenia religiosa di questa città, che proprio grazie al capitale simbolico della Chiesa Cattolica attrae la diversità religiosa, che si sente potenzialmente accolta e degnamente rappresentata (se a Roma il Cattolicesimo è così importante, allora significa che lì l'appartenenza religiosa è presa sul serio) per vedersi poi respinta nella quotidianità delle pratiche, segregata spesso nei rimasugli spaziali di quel che appare in effetti un monopolio religioso inamovibile.
Ci vediamo al TMC, Torpignattara Muslim Center, alle ore 17:30, per parlarne con i curatori, con Alessandra Broccolini e con Stefania Ficacci.