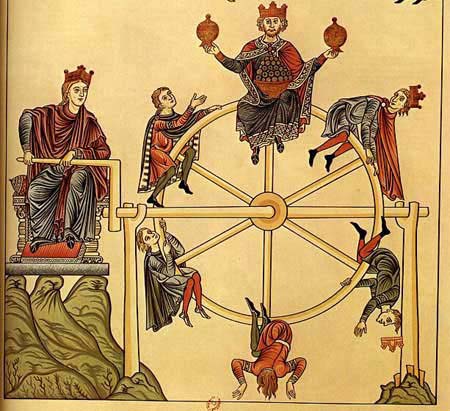Il "focus" del
Corriere di oggi (9 giugno) è dedicato alla
riforma universitaria del
3+2. Il giudizio è sintetizzato nel titolo:
Laurea breve bocciata. I pareri poi riportati sono discordanti, e se
Luciano Canfora parla della riforma come “follia”,
Umberto Eco ricorda che il 3+2 esiste in tutta Europa e l’Italia non ha fatto altro che adeguarsi. Certo, è stata l’Italia ad accettare il modello “nordico”, e non viceversa, come fa notare
Salvatore Settis nelle stesse pagine, ma forse questo dipende dal fatto che la “resa” delle università in quei paesi – in termini di rapporto con il sistema produttivo, di contatto tra università e società civile, di contributo alla crescita dei paesi dove quelle università si collocano, di risultati di ricerca – era infinitamente superiore rispetto all’Italia perché il nostro paese potesse costituire un modello di alcunché, in questo campo. Forse ci siamo adeguati al modello inglese (e non viceversa) perché le università inglesi erano, al momento di far partire la riforma,
infinitamente migliori delle nostre.
La riforma non sta andando bene, ma questo dipende più dalle contingenti interpretazioni che si sono date delle cose da fare, vale a dire il ridicolo sistema con cui si sono valutati i
crediti formativi, e il sistema dei “
moduli” dall’altro. La riforma sta fallendo perché chi doveva realizzarla (il corpo docente) l’ha di fatto
boicottata. Non sto dicendo che ci sia stato un esplicito accordo per farla saltare, ma la sua realizzazione compiuta avrebbe comportato un
mutamento tale negli stili di didattica che molti docenti non sono stati semplicemente in grado di compiere.
Le ragioni di questa inerzia del sistema docente possono essere molte, ma qui vorrei limitarmi a indicarne una, che possiamo sintetizzare come “
il rischio democratico della riforma”.
Il focus del
Corriere riporta una serie di dati statistici, alcuni dei quali vengono commentati negli articoli che li accompagnano. Così ci si compiace che l’
età media delle lauree (anche specialistiche) si sia abbassata rispetto al vecchio ordinamento, o ci si rattrista perché gli studenti partecipano al
programma Erasmus sono in calo, ma negli articoli nessuno sembra fare riferimento a
due dati che invece mi paiono
estremamente rilevanti per l’intensità del loro mutamento pre- e post riforma.
Il primo dato si riferisce alle
esperienze lavorative durante gli studi: mentre con il vecchio ordinamento ad aver lavorato durante l’università era solo il
55,1% degli studenti, con il nuovo ordinamento questo numero schizza al
73,2% per la triennale e al
70,9% per la specialistica. Questo dato può significare due cose: che frequentano l’università persone
già inserite nel mondo del lavoro che intendono migliorare le loro competenze (e le loro prospettive di carriera, immagino) qualificandosi ulteriormente; oppure che hanno iniziato a frequentare l’università persone che
un tempo sarebbero state attratte
direttamente dal mondo del lavoro dopo il diploma. Le due cose sono ovviamente vere entrambe, e se molti sono “tornati” a studiare dopo anni di lavoro, altri hanno continuato a studiare pur se la loro
condizione socio-economica li avrebbe, con un altro sistema, facilmente allontanati dal modo dello studio.
Questa interpretazione sembra confermata dal
secondo dato cui facevo riferimento, che è la percentuale di studenti che hanno
almeno un genitore laureato. Con il vecchio ordinamento questa percentuale era del
45,1%, vale a dire che, qualunque università aveste avuto modo di visitare fino al 1999,
quasi uno studente su due aveva un genitore già laureato. Ora questo numero è crollato al
23,5% per la triennale e al
31,1% per la specialistica. Chiunque abbia fatto un po’ di sociologia di base dovrebbe avere la consapevolezza della rilevanza di questo dato, che segnala un mutamento radicale nella
struttura sociale del paese. Non sono più i laureati a generare figli che si laureeranno (com’era di fatto prima della riforma del 1968), e non è più neppure vero che la laurea di un genitore è un fattore che
predice quasi al 50% l’eventualità che un figlio si laurei: oggi quella percentuale è scesa a
meno di un terzo per le lauree specialistiche e addirittura a
meno di un quarto per la triennale. Significa che la riforma ha scardinato il
sistema di casta dell’accesso all’istruzione terziaria, portando all’università nuove masse di studenti che
non portano da casa alcuna frequenza con l’alta istruzione. Perché nessuno sembra fare caso a questo dato? Dopo la riforma del Sessantotto si tratta del cambiamento strutturale più evidente e più importante che l’università italiana abbia attraversato, eppure molti stanno lì a discettare sul 3+2 come fosse un delirio o l’opera di un folle, senza tenere conto delle sue valenze profondamente
democratiche, se per democrazia intendiamo consentire a tutti, indipendentemente dal censo e dalla provenienza familiare, di accedere equamente alle risorse disponibili.
Ora, se si pensa alla struttura sociale dell’università della riforma, è evidente una “
lotta di classe” in corso: gli
studenti (che non hanno genitori laureati, che vengono dalle classi impiegatizie e lavoratrici, che non hanno “la Cultura” come consuetudine domestica, che devono imparare sui libri chi sia Proust e cosa sia la nostalgia borghese dei bei tempi andati) dovrebbero essere istruiti da un
corpus docente che invece è ancora almeno per la metà fortemente connotato in senso classista, docenti che vengono da famiglie “bene” in cui le ragazze studiavano il piano e i maschi tiravano di fioretto, famiglie soprattutto in cui “la Cultura” era un modo fondamentale per distinguersi socialmente, per distaccarsi dalla plebe cafona che ascoltava le canzoni di
Massimo Ranieri e leggeva al massimo
Grand Hotel. Ora quegli stessi docenti che con tanta fatica hanno
prodotto la loro
immagine sociale di se stessi dovrebbero “regalare” il loro sapere ai figli di quelle masse da cui loro si sono distinti:
non se ne parla neppure, mi pare scontato.
La riforma sta fallendo perché chi avrebbe dovuto realizzarla non poteva farlo pena la perdita del proprio
privilegio distintivo, e non si è mai visto una classe applicare una pratica sociale che porta alla propria
indistinzione, vale a dire alla propria
estinzione come classe.
La riforma si può ancora realizzare se quella
porzione del corpo docente che proviene dalle classi impiegatizie e operaie avrà il coraggio di allearsi con gli studenti, facendoli crescere socialmente e politicamente. Sono cioè i
docenti che vengono da famiglie di non laureati (come la mia) il fulcro politico della fase in atto, dato che sono gli unici ad avere di fronte un’alternativa. Mentre infatti i
docenti “borghesi” e gli
studenti “proletari” hanno di fronte un’unica prassi, che viene dalla loro storia di classe, i
docenti di estrazione proletaria debbono decidere se allearsi coi docenti borghesi in nome di una
distinzione acquisita (continuando di fatto ad essere
paria del mondo accademico, il cui potere è concentrato nelle mani della porzione borghese) oppure allearsi con gli studenti proletari, in nome della
comune origine sociale.