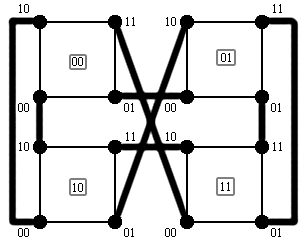Il mio post sul lutto perinatale ha suscitato molte reazioni, come potete vedere dai lunghi commenti. Mi dispiace sinceramente di aver ferito la sensibilità di persone che già hanno dovuto provare il dolore di quella che immagino sia la perdita assolutamente più irreparabile, vale a dire quella di un figlio, e a mia unica discolpa posso dire di non aver avuto l'intenzione di ferire nessuno veramente.
Con il mio post non intendevo sminuire quel dolore (che è tale nella misura in cui viene provato, non c'è nulla da sminuire o esagerare nel dolore degli altri) ma mi chiedevo come mai solo da qualche anno, "da noi" si sentisse la necessità di portarlo alla luce della discussione e dell'elaborazione pubblica. Certamente, perdite perinatali sono avvenute sempre (e con una frequenza molto molto maggiore più si va indietro nel tempo) ma non ho memoria di un'accettazione sociale pubblica di questo dolore: era solo questa considerazione che aveva mosso il mio post.
Durante le prime lezioni di antropologia, quando si tratta di parlare del ruolo che certe forme della comunicazione e della tecnologia hanno nel produrre relazioni sociali, faccio sempre un esempio.
Mio padre e mia madre hanno avuto sette figli, quattro femmine e tre maschi, ma hanno saputo il nostro sesso (e qualunque altra caratteristica fisiologica su di noi) solo al momento della nascita. Io, invece, ricordo pefettamente il momento in cui ho visto la faccia di Rebecca (la mia prima figlia, che ha otto anni) e della seconda figlia (Amanda, che ha un anno e mezzo). Le ho viste attorno al quarto mese di gravidanza, le ho viste dentro l'utero, e il ginecologo ci ha stampato una "foto" in cui i lineamenti di entrambe erano perfettamente riconoscibili.
Per Amanda (che è nata da una mamma diversa da quella di Rebecca) siamo andati in un centro diagnostico romano molto attrezzato e molto "lussuoso", e ricordo che il ginecologo era sorpreso che ad accompagnare Valeria incinta ci fossimo solo io e Rebecca. Di solito, ci ha spiegato, per occasioni come questa molti radunano il parentato allargato, tant'è che la sala dell'ecografia è attrezzata con un vero salottino appartato con un'ampio schermo alla parete dove viene proiettata l'immagine dell'ecografia che viene ripresa nella stanza a fianco, per dar modo a nonni e zii di assistere alla prima epifania del/la bambino/a.
Ai miei studenti dico che mio padre e mia padre potevano solo immaginarci, e lo facevano molto, molto vagamente a sentire i loro ricordi. Soprattutto mio padre, non potendo avere alcuna esperienza fisica della paternità fino al momento in cui ci ha visti, sono certo che ci ha amati fin da subito, fin da quando mia madre gli comunicava di essere incinta (non ho alcun dubbio su questo, e tutta la vita di mio papà sta a dimostrarlo), ma non ha potuto stabilire alcuna relazione emotiva con noi come veri esseri umani concreti, non semplici idee della sua mente.
Io, invece, ho potuto ricordarmi della faccia delle mie figlie mentre ancora erano nella pancia delle loro mamme: sapevo che erano femmine, non perché "me lo sentissi" (com'era una volta) ma perché me l'avevano detto. Avevo visto il labbro sporgente di Rebecca e il naso all'insù di Amanda e già facevo il gioco delle somiglianze molto prima che venissero partorite.
Per non parlare dell'analisi del sangue per le mie compagne (sono microcitemico, portatore sano di anemia mediterranea) dell'amniocentesi, dell'ecografia morfologica, della translucenza nucale, tutte analisi ed esami che avevano escluso una serie di gravi malattie.
Non intendo misconoscere il dolore dei genitori che hanno subito un lutto perinatale, e non credevo di aver detto nulla che potesse lasciarlo in alcun modo credere. Ma riconoscere che un dolore ha assunto una forma socialmente accettata non significa ammettere che sia universale nel tempo e nello spazio, né considerarlo come l'unica forma ragionevole di reazione a una perdita perinatale, quasi che chi continuasse a elaborarlo (anche con la rimozione) nel privato altro non sarebbe che uno scellerato o un represso. Le persone che conosco che hanno subito questa perdita sono persone sensibili, non certo mostri, ma non racconterebbero mai questo loro dolore in pubblico, a estranei, su un blog. Il loro modo di affrontare (superare/rimuovere) il dolore forse appartiene a un'altra epoca, forse è addirittura fuori moda, ma io credo che sia altrettanto legittimo di chi invece ritiene necessario esporlo pubblicamente. Ognuno ha diritto di affrontare il proprio dolore come meglio crede, ma chi lo rende pubblico avrà in più l'onere di vedersi interrogato sulla forma di quella sofferenza, senza che questo costituisca automaticamente un insulto.
Ho insegnato a Venezia, Lubiana, Roma, Napoli, Firenze, Cosenza e Teramo. Sono stato research assistant alla Queen's University of Belfast e prima ho vissuto per due anni in Grecia, per il mio dottorato. Ora insegno a Tor Vergata e nel campus romano del Trinity College di Hartford (CT). Penso che le scienze sociali servano a darci una mano, gli uni con gli altri, ad affrontare questa cosa complicata, tanto meravigliosa quanto terribile, che chiamano vita.
2011/12: INFORMAZIONI PER CHI AVEVA 12 CFU E TUTTI GLI MP3 DELLE LEZIONI
giovedì 28 gennaio 2010
mercoledì 27 gennaio 2010
Musicanti romani/romeni/romiti
Avevo pensato di fare la figata, aprendo un "evento" su Fb ma mi hanno risposto in tre! Ok, non sarò Luca Sofri che assume una redazione per il suo nuovo sito, ma speravo che la mia idea di produrre un documentario su Roma chiedendo ai musicisti/musicanti/cantanti romani (o gravitanti su Roma) di darmi una mano con la colonna sonora potesse attirare maggiormente l'interesse.
In sintesi: assieme a Federico Gnemmi, un mio bravo laureando che però di suo è videomaker/regista, stiamo mettendo a punto un documentario su "Roma città diversa", dove vogliamo far vedere come la dimensione storicamente locale di Roma (borgate storiche come Pietralata, Quarticciolo, Centocelle; i nuovi quartieri come Laurentino 38, Casilino 23, Tor Sapienza; le usanze "di paese" come la processione al Divino Amore o la festa dell'Immacolata a San Lorenzo o gli orti di Casale Rocchi) si incrocia con i nuovi flussi migratori (Torpignattara con i Bengalesi, il centro diurno Joel Nafuma della Chiesa di San Paolo entro le mura, il Centro Rifugiati di Pietralata) e con la perdita del tenue tessuto industriale della città (il Lanificio Luciani che diventa scuola di danza; la fabbrica di motori d'aereo sulla Prenestina che viene occupata dai blocchi precari metropolitani e diventa Metropoliz per poi dare accoglienza ai rom romeni sgomberati dalla via dell'aeroporto di Centocelle (il cosiddetto Casilino 700), che si contruiscono le case dentro il capannone della fabbrica con il supporto di un workshop di studenti di architettura di Roma3) e come tutto questo dipenda da/produca una città globalizzata in forme che poco hanno a che fare con la dimensione strettamente economica e coinvolgano invece gli aspetti culturali della globalizzazione. Come le vite delle persone normali (io, tu) vengano influenzate da questi flussi che si intersecano nella dimensione locale è un obiettivo primario del documentario, che vuole dare spazio visivo e sonoro a Roma come città in cui il processo di omologazione proprio non ce la fa (per fortuna) a prevalere.
Mi serve quindi musica di tutti i tipi: dagli stornelli all'hip-hop, dal metallo pesante al jazz da ambiente, dalla ballata rock alla canzone melodica, dalla dodecafonica alla etnica.
Se avete musica nel cassetto e vi interessa il progetto, scrivetemi a
mio nome punto mio cognome chiocciola gmail punto com
Se conoscete qualcuno che potrebbe essere interessato, per cortesia fate circolare. Vorrei mantenere una dimensione wiki o open source a questo progetto, per ora, ma non è detto che non si pubblichi con un editore commerciale, nel qual caso ognuno riceverebbe la sua quota di diritti.
In sintesi: assieme a Federico Gnemmi, un mio bravo laureando che però di suo è videomaker/regista, stiamo mettendo a punto un documentario su "Roma città diversa", dove vogliamo far vedere come la dimensione storicamente locale di Roma (borgate storiche come Pietralata, Quarticciolo, Centocelle; i nuovi quartieri come Laurentino 38, Casilino 23, Tor Sapienza; le usanze "di paese" come la processione al Divino Amore o la festa dell'Immacolata a San Lorenzo o gli orti di Casale Rocchi) si incrocia con i nuovi flussi migratori (Torpignattara con i Bengalesi, il centro diurno Joel Nafuma della Chiesa di San Paolo entro le mura, il Centro Rifugiati di Pietralata) e con la perdita del tenue tessuto industriale della città (il Lanificio Luciani che diventa scuola di danza; la fabbrica di motori d'aereo sulla Prenestina che viene occupata dai blocchi precari metropolitani e diventa Metropoliz per poi dare accoglienza ai rom romeni sgomberati dalla via dell'aeroporto di Centocelle (il cosiddetto Casilino 700), che si contruiscono le case dentro il capannone della fabbrica con il supporto di un workshop di studenti di architettura di Roma3) e come tutto questo dipenda da/produca una città globalizzata in forme che poco hanno a che fare con la dimensione strettamente economica e coinvolgano invece gli aspetti culturali della globalizzazione. Come le vite delle persone normali (io, tu) vengano influenzate da questi flussi che si intersecano nella dimensione locale è un obiettivo primario del documentario, che vuole dare spazio visivo e sonoro a Roma come città in cui il processo di omologazione proprio non ce la fa (per fortuna) a prevalere.
Mi serve quindi musica di tutti i tipi: dagli stornelli all'hip-hop, dal metallo pesante al jazz da ambiente, dalla ballata rock alla canzone melodica, dalla dodecafonica alla etnica.
Se avete musica nel cassetto e vi interessa il progetto, scrivetemi a
mio nome punto mio cognome chiocciola gmail punto com
Se conoscete qualcuno che potrebbe essere interessato, per cortesia fate circolare. Vorrei mantenere una dimensione wiki o open source a questo progetto, per ora, ma non è detto che non si pubblichi con un editore commerciale, nel qual caso ognuno riceverebbe la sua quota di diritti.
martedì 19 gennaio 2010
Amanda e il destino del linguaggio da Adamo a Babele
 A Rebecca (che ora ha più di otto anni) cantavo sempre Alla fiera dell'Est oppure Samarcanda come ninna nanna, ma quando è arrivata Amanda (che ora ha diciassette mesi) Valeria ha comprato alcuni libretti con i cd allegati: Ci vuole un fiore di Sergio Endrigo, La vecchia fattoria del Quartetto Cetra, Via dei matti, sempre di Endrigo, e La tartaruga di Bruno Lauzi. Rapidamente, per motivi noti solo a lei, la canzone di Lauzi è balzata in cima alla hit parade di Amanda, che l'ha eletta canzone del cuore. Di conseguenza, la tartaruga è diventata un suo animale totemico. Tra gli innumerevoli episodi, ricordo la visita allo zoo. Non ero sicuro di voler visitare anche il rettilario (già il bioparco di Roma è enorme e Amanda aveva sì e no un anno, temevo si sarebbe stancata) ma appena ha visto le tartarughe, Amanda è andata in estasi, gettando bacini attraverso il vetro e illuminandosi con il ditino perennemente puntato verso i rugosi rettili.
A Rebecca (che ora ha più di otto anni) cantavo sempre Alla fiera dell'Est oppure Samarcanda come ninna nanna, ma quando è arrivata Amanda (che ora ha diciassette mesi) Valeria ha comprato alcuni libretti con i cd allegati: Ci vuole un fiore di Sergio Endrigo, La vecchia fattoria del Quartetto Cetra, Via dei matti, sempre di Endrigo, e La tartaruga di Bruno Lauzi. Rapidamente, per motivi noti solo a lei, la canzone di Lauzi è balzata in cima alla hit parade di Amanda, che l'ha eletta canzone del cuore. Di conseguenza, la tartaruga è diventata un suo animale totemico. Tra gli innumerevoli episodi, ricordo la visita allo zoo. Non ero sicuro di voler visitare anche il rettilario (già il bioparco di Roma è enorme e Amanda aveva sì e no un anno, temevo si sarebbe stancata) ma appena ha visto le tartarughe, Amanda è andata in estasi, gettando bacini attraverso il vetro e illuminandosi con il ditino perennemente puntato verso i rugosi rettili.E poi, da molto tempo Amanda ha imparato a chiamare le tartarughe, a nominarle. Solo che le ha nominate decidendo lei come. La canzone di Bruno Lauzi (chi non la conosce?) parla di una tartaruga che impara a sue spese a non andare troppo veloce. Tra una strofa e l'altra c'è il classico pooo-popopò-pooo-popopò-pooo-popo-popò e da allora in poi po-po-po è diventata la parola che Amanda ha deciso significasse "musica" per cui ancora adesso (quasi un anno e mezzo) quando la mettiamo sul seggiolino in macchina pretende "po-po-po" per sopportare la tortura dell'imbracatura e la noia di restare immobile. Credo che sia partito da questa premessa il percorso battesimale della tartaruga. Nel corso della prima strofa, la tartaruga "che cosa mangerà / chi lo sa? Chi lo sa?". Anzi lo sappiamo benissimo: "due foglie di lattuga /poi si riposerà / a-a-a! a-a-a!". Bene, se "po-po-po" è la musica, ergo "a-a-a" è la tartaruga, e infatti Amanda chiama la tartaruga con questa triplice vocale ritmata (tecnicamente mi pare di poter dire che fa precedere la vocale da un piccolo colpo di glottide, che dà al tutto uno spessore sillabico nitido). Non siamo stati noi genitori a suggerirle di chiamare la tartaruga in quel modo, l'ha veramente deciso lei. Come Adamo, ha fatto come le pareva, ha battezzato la tartaruga con il suo "a-a-a" senza preoccuparsi affatto della "condivisione del segno" e di tutte le altre belle parole della semiotica. Alle prese con il linguaggio, l'ultima cosa che le è venuta in mente è stata la natura relazionale della comunicazione linguistica, la necessità di pervenire a una costruzione negoziata del segno: lei ha imposto al mondo (e alle tartarughe) il suo nome come una dittatura. Mi pare bellissimo questo rapporto vergine con il linguaggio: non chiedo in giro come si chiama quell'animale, ma io lo chiamo, io lo interpello, io lo porto all'esistenza con il mio nominarlo. Che vertigine da onnipotenza si deve provare quando si riesce ancora a ragionare così!
Ma Amanda non è sola, ha due genitori (e una sorella) che stanno sempre lì a metterla in riga, che vogliono insegnarle, che pretendono che lei impari. Dopo mesi di a-a-a in formato pupazzo, statuina, disegno, cartone animato e animale vivente, il linguaggio, tramite le relazioni sociali, ha iniziato a pretendere il conto da Amanda: non si dice a-a-a, si dice tar-ta-ru-ga.
Come si dice, Amanda?
a-a-a! Ha insistito beata, puntando il dito contro il pupazzo (statuina, disegno, cartone, animale) per portare la prova indessicale della sua competenza.
Ma il linguaggio non si arrende, insiste, è noioso fino a farti cedere. Al mio ennesimo tentativo di addomesticare la sua a-a-a, qualche giorno fa ho sentito Amanda rispondere con un groviglio di suoni che potrei trascrivere 'Unga!, che a volte diventa Kunga!
Adesso a-a-a e kunga convivono, e noi spingiamo sempre più per esiliare a-a-a, relegandola alla canzoncina, mentre tutte le altre epifanie della Ur-Tartaruga devono essere nominate kunga. Stiamo vincendo, com'è ovvio e forse com'è giusto.
Ma io penso alla a-a-a creata da Amanda, da lei voluta e amata visceralmente, e so che tra qualche mese (forse solo tra qualche settimana) non ci sarà più, sepolta dalla kunga che poco alla volta diverrà tartaruga in assetto effettivo.
Allora Amanda avrà imparato, sarà entrata con tutti noi dentro la convenzione del linguaggio, e non ricorderà più di quando chiamava le cose con il loro primo nome.
Chi scrive poesie, credo, cerca di non perdere contatto con la sua a-a-a.
martedì 12 gennaio 2010
Lutto perinatale
Dopo pranzo ho continuato a sistemare il course plan per Urban and Global Rome che tengo al Trinity College. Mentre cercavo un contatto per una delle uscite previste con gli studenti, ho trovato un pagina Fb dedicata a Babyloss info, mi sono visto il sito, che collega una rete internazionale di persone che hanno perduto un bimbo in età perinatale (vale a dire poco prima o poco dopo la nascita). Il sito è a sua volta gestito da CiaoLapo Onlus, associazione costituita da due genitori che hanno perso il loro bambino (Lapo, appunto) pochi giorni prima del parto. Ho più di una persona cara nella mia famiglia che ha vissuto questo lutto, ma non ho mai pensato alla sua socializzazione. Mi colpisce soprattutto la categoria "morte perinatale" che rende il parto un momento non discriminante nella nostra concezione della persona. Il ricordo diventa una posizione identitaria fondamentale, e il sostegno reciproco, se da un lato spinge al superamento delle condizioni medico-clinche che possono aver causato la morte (con un intento quindi preventivo), è in buona parte orientato alla condivisione del lutto, alla sua socializzazione e quindi, quel che mi colpisce più di tutto, alla sua definizione. E' evidente che per molti di noi (penso appunto alle persone che io conosco) una perdita perinatale non è percepita come legittimamente elaborabile in un lutto sociale, ma come un dolore del tutto privato, che privatamente va rimosso. Mentre, ad esempio, posso parlare con quelle persone di nostri cari comuni, non posso parlare del feto o del bimbo morto alla nascita: non ne ho mai parlato in anni e anni, un vero tabù che una posizione come quella di Babyloss tende a negare totalmente, inscrivendo quindi la perdita dentro la socialità della piena umanità.
Con tutto il rispetto per chi ha sofferto un simile dolore, mi chiedo quanto questa per me nuova concezione della perdita perinatale dipenda dalle tecnologie disponibili (soprattutto l'ecografia prenatale) che consentono di vedere il feto e quindi di instaurare con lui un rapporto già sociale pur se prenatale. Dice la mamma di Lapo:
i controlli segnalavano un bambino grosso e dalle guance paffute ("questo bambino è bello come un angelo, guardate che guance e che gambe che ha" sono le parole che hanno accompagnato l'ultima ecografia di controllo, fatta tre giorni prima della sua morte).
Se Lapo, come è stato per millenni, non fosse stato visibile prima della nascita, avremmo gli strumenti per elaborare la categoria di "lutto perinatale"?
lunedì 11 gennaio 2010
Rosarno
Faccio l'antropologo, dicono, e quindi dovrei professionalmente interessarmi di Rosarno, di quel che succedeva lì da anni (vale a dire le condizioni disumane in cui vivevano i lavoratori irregolari, reclutati dai caporali della criminalità organizzata per lavorare nella raccolta agricola), quel che è successo nei giorni scorsi (vale a dire lo "sfizio" di bulletti di paese che non sanno cosa fare e sparano pallini sugli immigrati; la rabbia tra gli africani che monta sorda, che produce ribellione e violenza contro "i bianchi"); e quel che sta succedendo (vale a dire l'occupazione del consiglio comunale, la "caccia al negro", "il repulisti", le solite parole piene di buon senso dell'immarcescibile ministro Maroni, che ha visto bene di soffiare sul fuoco casomai gli animi non fossero abbastanza caldi). Dovrei occuparmene perché si tratta di problemi di ordine sociale in cui l'elemento "razziale" conta non poco: hanno sparato a dei negri, e la rivolta ha colpito dei bianchi, che sono riusciti a far cacciare i "negri", mentre i romeni e gli altri UE prenderanno il loro posto, se mai ci sarà bisogno di andare a raccogliere clementine (perché pare che tutto il casino sia stato montato proprio per provocare gli africani e avere un pretesto per cacciarli, dato che gli irrisori prezzi di mercato e le sovvenzioni europee rendono controproducente la raccolta degli agrumi per molti agricoltori che si avvalevano della manodopera africana). Tutto questo vedrebbe la mia disciplina in prima fila, ma chi mai avrà voglia si sentirsi parlare di "superamento dei pregiudizi razziali", o di "sistema di aspettative culturali" per cui se vivi in un tugurio e lavori come uno schiavo per 25 euro al giorno significa che vieni da condizioni di vita in cui le tue aspettative sono anche inferiori? Qui siamo tutti di fretta, c'è un problema e lo si deve risolvere, in tempi rapidi.
Annuncio solo che a Castel Volturno, mi dice una mia conoscenza nigeriana, sta organizzandosi una malavita africana, per cui pestaggi su altri africani denunciati alla Polizia non vengono indagati e quindi temo che a breve ne vedremo delle belle.
Annuncio a chi non se ne fosse accorto che lungo il muro esterno della stazione Termini di Roma (lato via Marsala) ogni sera si accalcano per dormire decine di africani, molti di loro in attesa di sapere se la loro richiesta di asilo verrà accolta, tutti esasperati da un contesto sociale che non dà loro alcuna opportunità. Annuncio per i distratti che ghetti, tuguri, spazi malsani e condizioni di vita terrificanti sono comuni per molti immigrati senza permesso di soggiorno, molti dei quali lavorano sottopagati non solo a Rosarno, ma anche nelle nostre metropoli, giusto a pochi metri da dove stai leggendo questo post.
Possiamo aspettare il prossimo tentativo di linciaggio, il prossimo bruciato vivo, sparato, sprangato. Oppure possiamo aspettare la prossima rivolta di esseri umani esasperati e abbrutiti, che se la prenderanno con i simboli del sopruso, fossero anche una mamma e i suoi due figli sulla macchina. Possiamo aspettare che "l'amore vinca sull'odio", come nei romanzi di Liala, oppure possiamo provare a cercare di documentare meglio quel che ci sta attorno, che sta proprio dietro l'angolo di casa nostra, non solo nella lontana Rosarno. Chiedo agli amministratori se non ritengano finalmente necessario un serio lavoro di documentazione etnografica dello stato di fatto dell'immigrazione "irregolare" in Italia. Sapere quante Rosarno ci sono in giro, sentire cosa si aspettano, cosa sperano e di cosa disperano quelli che le popolano, bianchi e neri. Aprire spazi di confronto senza parole d'ordine preconfezionate, provando a informare di qua e di là di quella barricata che si sta alzando sempre più verticale, sempre più invalicabile. Cosa aspettiamo a investire seriamente nell'informazione, invece che nella reciproca paura?
Annuncio solo che a Castel Volturno, mi dice una mia conoscenza nigeriana, sta organizzandosi una malavita africana, per cui pestaggi su altri africani denunciati alla Polizia non vengono indagati e quindi temo che a breve ne vedremo delle belle.
Annuncio a chi non se ne fosse accorto che lungo il muro esterno della stazione Termini di Roma (lato via Marsala) ogni sera si accalcano per dormire decine di africani, molti di loro in attesa di sapere se la loro richiesta di asilo verrà accolta, tutti esasperati da un contesto sociale che non dà loro alcuna opportunità. Annuncio per i distratti che ghetti, tuguri, spazi malsani e condizioni di vita terrificanti sono comuni per molti immigrati senza permesso di soggiorno, molti dei quali lavorano sottopagati non solo a Rosarno, ma anche nelle nostre metropoli, giusto a pochi metri da dove stai leggendo questo post.
Possiamo aspettare il prossimo tentativo di linciaggio, il prossimo bruciato vivo, sparato, sprangato. Oppure possiamo aspettare la prossima rivolta di esseri umani esasperati e abbrutiti, che se la prenderanno con i simboli del sopruso, fossero anche una mamma e i suoi due figli sulla macchina. Possiamo aspettare che "l'amore vinca sull'odio", come nei romanzi di Liala, oppure possiamo provare a cercare di documentare meglio quel che ci sta attorno, che sta proprio dietro l'angolo di casa nostra, non solo nella lontana Rosarno. Chiedo agli amministratori se non ritengano finalmente necessario un serio lavoro di documentazione etnografica dello stato di fatto dell'immigrazione "irregolare" in Italia. Sapere quante Rosarno ci sono in giro, sentire cosa si aspettano, cosa sperano e di cosa disperano quelli che le popolano, bianchi e neri. Aprire spazi di confronto senza parole d'ordine preconfezionate, provando a informare di qua e di là di quella barricata che si sta alzando sempre più verticale, sempre più invalicabile. Cosa aspettiamo a investire seriamente nell'informazione, invece che nella reciproca paura?
Ancora su cos'è l'etnografia
In vista dei moduli che partono tra poco a Tor Vergata, mi sto leggendo una raccolta di saggi curata da Francesca Cappelletto (putroppo scomparsa prematuramente proprio mentre stava lavorando alla cura di questo volume), Vivere l'etnografia, Firenze, Seid, 2009. E' una raccolta egregia (si vede la mano di Lenardo Piasere, che di etnografia se ne intende), e mi sono messo a schedare l'articolo di Jean-Pierre Olivier de Sardan che proprio Francesca nel 2004 mi aveva chiesto di tradurre per questa raccolta. Ero veramente oberato di impegni e avevo dovuto rinunciare. Il testo è poi stato mirabilmente tradotto da Nadia Breda e Franca Trentin, e sebbene sia illuminante nel suo complesso, proprio per come riesce a raccontare in modo piano e molto operativo una pratica come la ricerca sul campo, particolarmente riottosa a qualunque incasellamento metodologico, c'è un passo che merita di essere citato per esteso, per come riesce a sintetizzare il valore dell'etnografia:
Il saggio prosegue illuminando le "quattro grandi forme di produzione dei dati" (osservazione partecipante, colloquio, procedure di censimento e raccolta di fonti scritte) e articola una riflessione magistrale sulla "politica del campo". Lo consiglio vivamente (assieme a tutto il libro di Francesca Cappelletto) a quanti hanno interessa per la metodologia di ricerca etnografica, che so oggi essere non solo antropologi.
Il carattere "iniziatico" del campo, più volte rilevato, spesso sarcasticamente, dai commentatori della tradizione antropologica, non è soltanto una faccenda di mito o di rito, è anche, e senza dubbio soprattutto, una faccenda di apprendimento pratico, nel senso che chi apprende impara innanzitutto facendo. Bisogna aver condotto personalmente delle interviste con una traccia prefabbricata di domande per rendersi conto di quanto gli interlocutori restino inibiti da un quadro troppo stretto o troppo unidirezionale. Bisogna essersi confrontati con numerosi malintesi tra chi fa l'indagine e chi ne è oggetto per essere capaci di individuare i controsensi che cospargono ogni conversazione di ricerca. Bisogna aver imparato a padroneggiare i codici locali di cortesia e buona creanza per sentirsi infine a proprio agio nelle chiacchierate e conversazioni improvvisate, che sono spesso le più ricche di informazioni. Bisogna aver dovuto spesso improvvisare con goffaggine per diventare poco alla volta capaci di improvvisare con abilità. Bisogna, sul campo, aver perduto tempo, tanto tempo, una quantità enorme di tempo, per capireche questi tempi morti erano necessari (Jean-Pierre Olivier de Sardan, "La politica del campo. Sulla produzione di dati in antropologia", in F. Cappelletto (a cura di), Vivere l'etnografia, Firenze, Seid, 2009, pp. 27-63; la citazione è da p. 30).
Il saggio prosegue illuminando le "quattro grandi forme di produzione dei dati" (osservazione partecipante, colloquio, procedure di censimento e raccolta di fonti scritte) e articola una riflessione magistrale sulla "politica del campo". Lo consiglio vivamente (assieme a tutto il libro di Francesca Cappelletto) a quanti hanno interessa per la metodologia di ricerca etnografica, che so oggi essere non solo antropologi.
sabato 9 gennaio 2010
Blogging Lévi-Strauss
Questo sarà pubblicato sul prossimo numero di AM/Antropologia Museale. Grazie a tutti quelli che cito e le mie scuse ai blogger che hanno scritto di L-S ma non cito (forse perché non li ho letti, forse perché non ci stavano come spazio).
La morte di Claude Lévi-Strauss ha sollevato ovvio clamore in tutto il mondo, data la statura intellettuale del personaggio e la sua notorietà planetaria. Può essere quindi interessante una brevissima (e necessariamente incompleta) rassegna delle reazioni registrate su Internet.
La ricerca dell’entrata “Claude Lévi-Strauss” su Google restituisce “circa 1.620.000” pagine, ma se si tralasciano le voci delle diverse enciclopedie online, gli innumerevoli necrologi ripresi dalla carta stampata (sono 64.000 le pagine restituite dalla ricerca “claude levi strauss death”) e le note biografiche riportate dai siti espressamente dedicati all’antropologia, rimane un piccolo corpus di post pubblicati su blog generici o comunque non gestiti da antropologi.
L’immagine generale che se ne ricava è in parte lontana dalla figura istituzionale di Lévi-Strauss, e decisamente distante dal Lévi-Strauss con il quale siamo (stati?) soliti confrontarci “dentro la professione”, per così dire.
Incredibile a dirsi, nei blog gestiti da americani il sentimento più comune per la morte dell’ultracentenario antropologo è stata la sorpresa, dettata dal fatto che il mondo anglosassone evidentemente considerava Lévi-Strauss già morto da un pezzo. Sul blog di lingua inglese orbis quintus l’autore commenta la notizia con queste parole: “Sono un po’ imbarazzato, dato che pensavo fosse già morto”, e la sorpresa è confermata in un commento al post: “Nei miei corsi di antropologia ci si riferiva a lui sempre con il passato remoto, dal che ne deduco che anche i miei professori pensavano che fosse morto”.
Questo tipo di annotazioni appare di frequente, riporto ad esempio un altro commento a un breve post sul blog Stephen Bodio’s Querencia: “Wow! Non avevo proprio idea che fosse ancora in giro dopo così tanto tempo! Ho studiato le sue cose un sacco di anni fa per la mia laurea in antropologia, e già allora era considerato vecchio!”. Di questo blog è interessante riportare anche il breve post originale, che forse riesce a trasmettere il senso della ricezione “media” di questo autore negli Stati Uniti. Scrive Reid Farmer:
Claude Levi-Strauss [sic, senza accento], un antropologo culturale francese, è morto all’inizio di questa settimana all’età di cent’anni. È stato un gigante dell’antropologia culturale e corrispondeva molto bene all’immagine stereotipata dell’intellettuale francese. È stato uno dei fondatori dello strutturalismo e ha fatto di tutto per dimostrare che la raffinatezza e l’elaborazione delle mitologie e delle religioni anche delle società più “primitive” ci dimostrano che tutti noi abbiamo capacità intellettuali simili.
Mi ricordo di aver letto il suo Tristi tropici come matricola per un corso di introduzione all’antropologia culturale. Devo riconoscere che era un testo troppo sofisticato e teorico perché il mio cervello di diciottenne riuscisse veramente ad afferrarne il senso. La cosa principale che mi è rimasta è la sua affermazione che i miti usano gli esseri umani per riprodurre se stessi.
Il suo lavoro è così lontano nel tempo, e lui è vissuto così a lungo, che veramente sembra appartenere a un’altra era. Vedere il suo necrologio è stato un po’ come aprire il giornale e trovarci la notizia della morte recente di Franz Boas o Alfred Kroeber.
Sempre per rimanere tra i bloggers americani, molto successo ha riscosso il vecchio equivoco tra il cognome dell’antropologo e la quasi omonima marca di abbigliamento e jeans, per cui non sono mancate le battute del tipo “I suoi jeans continueranno a vivere” e, come didascalia di una foto di due indigeni nudi: “I Bororo hanno scelto di non indossare i pantaloni in segno di lutto per la morte di Lévi-Strauss”. Dello stesso macabro tenore la battuta che “in suo onore tutti i pantaloni saranno indossati a mezz’asta fino al calar del sole”. Si fa notare, tra i commenti, un laconico ed efficace “Riposi in jeans”.
Il tono, come si vede, è in genere tra lo scanzonato e l’incredulo. Più interessante invece seguire sulla rete la diatriba sulla cultura di appartenenza di Lévi-Strauss. Tzvee Teaneck, ad esempio, nel suo Tzvee’s Talmudic Blog si occupa dell’antropologo solo in quanto ebreo: “Claude Lévi-Strauss era ebreo? Sì, il grande antropologo appena scomparso all’età di cent’anni era ebreo e nipote di un rabbino”. Il tema sembra interessare più di un blogger (a volte con commenti dal tono antisemita) e vale la pena di citare un passo significativo di un post di Mel Konner, che si definisce un ebreo ortodosso che ha perduto la fede:
Per Lévi-Strauss, come per Boas e per altri antropologi ebrei, sussisteva un’ulteriore conseguenza nell’essere un outsider culturale: questo aspetto li spingeva a guardare con simpatia alle culture più semplici, che la maggior parte dei loro contemporanei giudicava con disprezzo. Il giovane intellettuale che probabilmente non si sentiva del tutto francese — il cui popolo era costretto a nascondersi e veniva ucciso a causa dei suoi costumi bizzarri e isolati – divenne il ricercatore sul campo che attraversò la foresta amazzonica per registrare i bizzarri costumi di popoli ancor più isolati, rispettandoli e preservandoli per i posteri.
L’immagine finale dell’ebreo inconsapevole pronto a penetrare la foresta in nome della diversità ci consente di aprirci a un’altra rappresentazione comune nel mondo della rete, vale a dire quella dell’etnografo avventuroso. Non si contano le foto del giovane e barbuto Lévi-Strauss alle prese con il suo rapido e notoriamente impacciato fieldwork, ma l’immagine che ne emerge è quella decisamente romantica di un giovane Indiana Jones sempre pronto a partire per una nuova avventura. La sovrastima della dimensione eroica dell’antropologo non cede neppure di fronte alle esplicite ammissioni dello stesso. Dopo aver riportato la celeberrima pagina iniziale di Tristi tropici (“Odio i viaggi e gli esploratori…”), Guglielmo, autore del blog Mi punge vaghezza… non si trattiene dal commentare, rivelando la comune convinzione che Lévi-Strauss fosse uno spericolato esploratore: “Sorprendente mi è sembrato che un antropologo di tale fama, famoso in tutto il mondo per i suoi studi e le sue ‘missioni’ nei luoghi più inesplorati del mondo, dichiari la sua ‘ostilità’ al viaggio”.
Eppure, tra i blogger, il riferimento alle pagine di Tristi tropici è costante. Ci sono, è vero, tentativi di presentare un quadro più compiuto della sua teorizzazione strutturalista (notevole in questo senso il pezzo che l’infaticabile Annarita Ruberto ha postato sul suo blog dedicato alla didattica, Scientificando, sintomaticamente titolato “Lévi-Strauss uomo strutturalista e vero Galilei del Ventesimo secolo”) ma il testo citato costantemente è quello più dichiaratamente letterario, come nel post che Paola Tassinari ha presentato sul suo blog, Il forum di Teoderica, oppure facendo riferimento ai passi più esistenzialisti della scrittura dell’antropologo, con citazioni decisamente lontane dall’immagine nitida dei cristalli strutturali, come quella riportata da Batsceba Hardy nel suo blog:
O vivere la vita nel modo più soddisfacente possibile, e allora comportarsi come se le cose avessero un senso pur sapendo che in realtà non ne hanno nessuno: restare lucidi, lasciarsi portare, andare all’avventura. O altrimenti ritirarsi dal mondo, suicidarsi oppure condurre un’esistenza da asceta tra le foreste e le montagne.
Un raro caso in cui riemerge la lucida razionalità dello scienziato sociale è quello presentato in uno dei blog più seguiti della rete, vale a dire Lipperatura di Loredana Lipperini, che ha scelto di ripubblicare come post un famoso pezzo scritto da Lévi-Strauss dopo la morte di Lady Diana, e rivolto a sondare il ruolo del fratello della madre (e quindi il legame matrilineare) nei sistemi di parentela europei. Si tratta di un pezzo anche tecnico, ma i commenti positivi sembrano indicare un sincero apprezzamento dei lettori.
In conclusione, possiamo dire che nella Rete il grande antropologo francese diventa facilmente un’icona romantica o lo spunto di riflessioni sull’esistenza e sull’alterità, una figura di sofferente filosofo più che un rigoroso scienziato, ma non è detto che questa rappresentazione molto umana e molto poco apollinea (Lévi-Strauss vittima di banali giochi di parole; Lévi-Strauss ebreo che ha smarrito la “sua vera cultura”; Lévi-Strauss improbabile esploratore “nei luoghi più inesplorati del mondo”) sia fallace, come ci ha dimostrato la famosa lettura di Tristi tropici offertaci più di vent’anni fa da Clifford Geertz (Clifford Geertz, “The World in a Text. How to Read ‘Tristes Tropiques’”, in Works and Lives. The Anthropologist as Author, Stanford, Stanford University Press, 1988, pp. 25-47. Traduzione italiana “Il mondo in un testo. Come leggere «Tristi tropici»”, in Opere e vite. L’antropologo come autore, Bologna, il Mulino, 1990, pp. 33-55.
lunedì 4 gennaio 2010
Cos'è l'etnografia
Sto leggendo un rapporto di ricerca di Eric Michaels, un tipo in gamba morto troppo giovane, quando ancora non c'era rimedio per chi si prendeva l'Aids. Per tre anni, tra il 1982 e il 1985, Michaels ha studiato l'impatto della televisione (arrivata allora da poco, con il satellite) su alcune comunità aborigine australiane. A parte gli interessantissimi risultati della sua ricerca (che sto riportando nel terzo capitolo del mio fantomatico prossimo libro), nella prefazione sintetizza in modo perfetto il metodo etnografico, vale a dire l'impegno ad acquisire informazioni senza questionari, senza registratori e sfilze di domande (si dice: interviste strutturate) e senza tutto l'armamentario solitamente "scientifico" che si potrebbe attribuire a una disciplina che pretende di fornire una conoscenza adeguata di culture diverse.
Molte volte mi rendo conto che fatico a spiegare ai miei studenti (o a quelli che lo vogliono sapere) perché sono convinto che la pratica etnografica (per quanto poco "operazionalizzabile", o proprio per questo motivo) sia uno strumento di ricerca fondamentale se si vogliono capire alcuni meccanismi nascosti delle culture, e anche ora, che sto cercando di fare una ricerca sui consumi di mass media e social networks, mi trovo a dover giustificare la stramberia di un metodo che non ha metodo, e spiegare perché facendo questo lavoro tante volte vale la pena di perdere tempo. Ci sono ovviamente bellissimi libri che spiegano cos'è l'etnografia, ma in poche righe Michaels racconta concretamente (ecco: etnograficamente) perché non ci sarà mai survey che possa fornire la ricchezza di un'etnografia fatta con tutto il tempo che ci vuole:
In generale, mi sono tenuto alla larga dalle interviste. Porre domande in forma diretta è considerato estremamente maleducato secondo l'etichetta aborigena (von Sturmer 1981). Gli individui legati alla tradizione si premuniscono di assicurare che solo gli anziani autorevoli "parlano a riguardo" di questioni specifiche, così che i singoli individui, interrogati con diverse domande, diranno di non sapere nulla sull'argomento. Il ricercatore può essere indirizzato alla persona adatta, oppure semplicemente ignorato, che in termini tradizionali può essere un modo cortese per non enfatizzare la maleducazione dell'intervistatore. Ma gli anziani autorevoli, per essere tali, dimostrano la loro autorità mantenendo il controllo del dialogo pedagogico. Si viene istruiti secondo una sequenza prestabilita, che è determinata dalla tradizione e non dal desiderio del ricercatore di riempire le caselle di un questionario o di perseguire i suoi specifici obiettivi di ricerca. La maggior parte di quel che so è costituito da quello che le persone hanno scelto di insegnarmi. E quando, nella mia impazienza, ho imposto le mie domande o ho forzato alcune tematiche, le risposte che ne ho ricavato si sono rivelate inaffidabili e sospette, a prova dell'innata cortesia degli aborigeni e del loro desiderio di cooperare, rivelando più sulla natura arrogante dell'intervista che non sulle conoscenze dell'intervistato [...] La gran parte di quel che so e presento in questo rapporto mi viene dall'aver lavorato assieme agli aborigeni per tre anni e dall'aver condiviso le mie attività con loro. Si è trattato soprattutto di lavoro con i video, ma ha incluso anche battute di caccia, partecipazione a cerimoniali, commissioni varie, prendere parte alle danze comunitarie e alle assemblee (Eric Michaels, Aborigenal Invention of Television.Central Australia 1982-86, Canberra, Australian Institute of Aborigenal Studies, 1986, p. xviii).
Certo, non tutti sono aborigeni e non tutti quindi condividono questo sistema culturale, così specifico riguardo alla comunicazione. Ma il punto è proprio questo: il concetto di "intervista" è altrettanto specifico e altrettanto culturalmente determinato, nasce dentro un'ottica dell'elicitazione dell'informazione che non è sicuramente universale. Come si può pretendere di applicarla in generale come modo per raccogliere informazioni attendibili? Chiunque ha praticato l'intervista sa benissimo che la persona intervistata immediatamente cambia postura, si mette nell'ottica dell'intervistatore, cerca di "accontentarlo", il che significa che fornisce risposte quasi sempre fuorvianti.
La ricerca etnografia, invece, si fonda sullo scambio comunicativo, sulla conversazione. E una conversazione, per essere tale, ha bisogno di tempo, di molto tempo. Per questo l'etnografia è fuori moda. Per questo può offrire risultati a cui nessun altro metodo di indagine può neanche sognarsi di aspirare.
La ricerca etnografia, invece, si fonda sullo scambio comunicativo, sulla conversazione. E una conversazione, per essere tale, ha bisogno di tempo, di molto tempo. Per questo l'etnografia è fuori moda. Per questo può offrire risultati a cui nessun altro metodo di indagine può neanche sognarsi di aspirare.
Iscriviti a:
Post (Atom)